Greg Gorman è considerato uno degli autori più noti della ritrattistica moderna e delle celebrità. Il mondo di Hollywood, le rockstar e i grandi sportivi hanno trovato in lui un professionista in grado di offrire uno sguardo contemplativo, intrigante, grazie a un personalissimo dosaggio della luce.
L’ombra, per Greg Gorman, gioca un ruolo importante perché rappresenta quella porzione di spazio inaccessibile allo spettatore, stimolandone la curiosità e l’immaginazione. Dallo stile inconfondibile, è un autore esigente e attento a ogni minimo dettaglio, dalle messe in scena alla postura, dall’espressione del volto all’esaltazione delle masse muscolari. Le sue sono immagini anticonformiste, capaci di restituire tutto il sapore della complicità che si instaura tra il fotografo e il soggetto.
Intervista a Greg Gorman
Hai scoperto la fotografia a diciotto anni. Ricordi quei momenti?
«Dopo aver fotografato un concerto di Jimi Hendrix – è stata la mia prima incursione nelle fotografia – sviluppai la pellicola nella camera oscura di un mio amico il mattino successivo. Quello che ricordo in maniera più vivida è stato vedere quelle immagini comparire misteriosamente dal foglio di carta bianca immerso nel liquido di sviluppo. Da quell’istante capii di aver trovato la mia vocazione».
Pensando a una professione, come ti immaginavi? Fotografo di moda o fotoreporter?
«Onestamente, nessuno dei due. Il mio primo incarico è stato come fotogiornalista perché era ciò che avevo studiato all’Università del Kansas. Tuttavia, il mio interesse fin dall’inizio è sempre stato il fotografare le persone».
Cos’è stata per te la fotografia e cosa significa oggi essere fotografo?
«La fotografia per me ha sempre riguardato la rottura delle barriere e delle maschere di coloro che scelgo di fotografare alla ricerca della loro vera identità e personalità. L’ho sempre vista come una sfida. Oggi, essere un fotografo significa piuttosto ricambiare e condividere in termini di insegnamento. Trovo stimolante condividere il mio mestiere e la mia visione con coloro che sono ancora molto appassionati e desiderosi di apprendere; aiutarli a trovare la loro voce attraverso la fotografia».
Quanto la tua educazione del Midwest e la tua personalità ti hanno aiutato nel gestire i momenti di scatto durante lo shooting soprattutto di fronte alle star?
«Essere cresciuto in una parte dell’America più tradizionale e neutrale – anche se purtroppo si trovano molti sostenitori di Trump –, mi ha dato l’equilibrio necessario per gestire gli alti e bassi di queste personalità così diverse e talvolta incerte».
Quali sono le doti che riconosci per un buon fotografo di ritratto?
«Innanzitutto deve essere un buon ascoltatore, capace di valutare ogni situazione ed essere anche un po’ psicologo. Questo soprattutto per anticipare le esigenze dei clienti, le loro idiosincrasie e preoccupazioni. Chiaramente, è necessario essere in grado di vedere e capire la luce in relazione a ogni singolo soggetto e come questa si possa meglio tradurre in una natura comunicativa. Devi essere un buon comunicatore per conquistare la fiducia della persona che sta dall’altra parte dell’obiettivo».
Ti riconosci nel termine perfezionista? E, invece, quanto ritieni importanti l’empatia e all’essere in sintonia con la persona da ritrarre per giungere a un valido risultato?
«Non ho mai sentito di aver realizzato l’immagine perfetta! C’è sempre qualche elemento che ritengo possa essere migliorato in ogni foto che scatto e quindi considero, in qualche modo, me stesso un po’ un perfezionista. Dico sempre ai miei studenti che quando sentono di aver fatto lo scatto perfetto è il momento di appenderlo».
Tra le tue immagini più iconiche, quali ricordi con maggior affetto e perché?
«Probabilmente definirei la mia immagine più iconica quella di Andy Warhol. La cosa divertente è che Andy mi ha chiesto se volevo scattare un suo ritratto per la L.A. Eyeworks. la campagna pubblicata ogni mese sulla sua rivista Interview . Aveva appena firmato un accordo con Ford Models e pensava che questa fosse una buona occasione. All’epoca non ci davo molto peso perché eravamo amici e spesso lavoravo per la sua pubblicazione. Si è rivelata, tuttavia, la mia immagine più ricercata».
Hai ritratto Michael Jackson con una tarantola sul viso. Com’è nata l’idea?
«Ho lavorato spesso con Michael. Era un soggetto eccezionale e aveva sempre grandi idee. Prima di ciascuna delle nostre sessioni fotografiche, solitamente mi telefonava per discutere delle idee per le riprese. Parlavamo a lungo. In questa particolare occasione, mi aveva raccontato che le sue tarantole da compagnia avevano appena fatto la muta e voleva portare le pelli per provare a utilizzarle. Una di queste l’abbiamo attaccata al volto di Michael e ho realizzato lo scatto».
Immagini senza tempo, sfondi molto minimalisti, illuminazione classica. Ti riconosci in questo stile?
«Ma certamente! Ho sempre avuto una predilezione per il soggetto posto al centro e di fronte e, molto spesso, in primo piano. Il mio stile di illuminazione, che rappresenta una forte relazione tra le luci e le ombre, si concentra sulla riproduzione di ciò che è più importante nelle alte luci e su ciò che è meno significativo nelle ombre. Il mio stile è abbastanza semplice e consente al soggetto di essere il punto centrale delle immagini piuttosto che della situazione o del set».
Quali caratteristiche deve possedere una buona fotografia di ritratto?
«Un buon ritratto dovrebbe disegnare una persona nell’immagine, ma non necessariamente rispondere a tutte le domande, lasciando qualcosa all’immaginazione. Questo credo possa riportare l’osservatore a rileggere l’immagine più di una sola volta».
In questi mesi sono in mostra le tue fotografie alla 29 Arts in Progress gallery di Milano. Com’è nato questo sodalizio con Eugenio Calini e Luca Casulli?
«Siamo stati presentati reciprocamente dal mio caro amico Amedeo Turello, che inizialmente mi aveva invitato a far parte di una mostra collettiva. Sono stati così solidali e gentili da includermi ora in diverse mostre».
Cosa desidereresti che il visitatore di una tua mostra portasse con sé uscendo dallo spazio espositivo?
«Molte mie stampe! No, seriamente, spero che prima di tutto apprezzino la mostra, ma anche che escano con una migliore comprensione di chi chi sono e di ciò che sto facendo come artista».
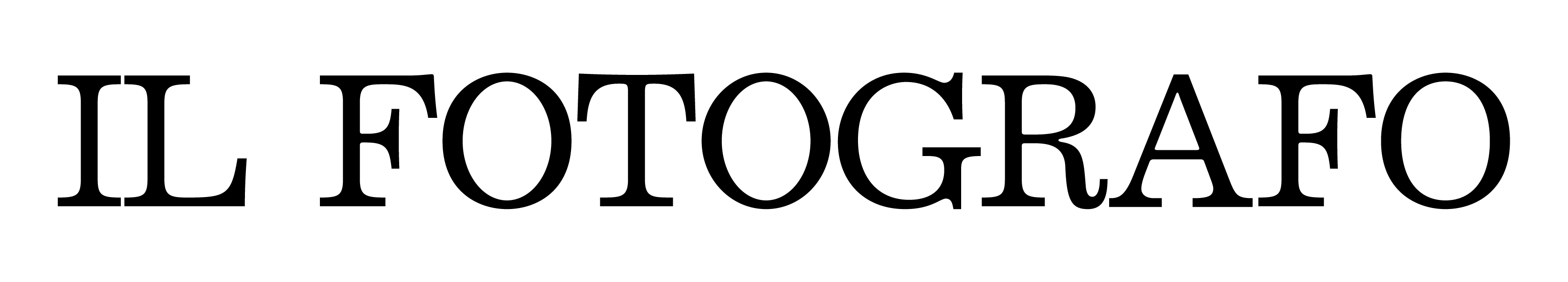
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





