Ha preso in mano la prima macchina fotografica a ventidue anni. Era una Nikon F2 con un 24 mm. Da allora non ha più abbandonato il suo compito: raccontare l’uomo. Si riconosce parte della vecchia scuola, quella delle linee ben definite. «Il mosso non è detto che sia da eliminare – racconta –, però poi la gente lo deve capire. Mi ricordo che una volta, a Panorama, mi chiesero delle foto sul Palio. Ho pensato a un panning per dare tutta la dinamicità della scena. Mi raccontarono che il direttore era infuriato vedendo tutto quel mosso. Gli ho fatto sapere che la stessa foto l’aveva pubblicata Life».
Intervista a Francesco Cito
La fotografia cos’è per te? Una passione, un’avventura?
«Direi che sono entrambe le cose. È stata e rimane tutt’oggi una passione. È anche un’avventura. Da bambino mi ero innamorato dei lavori di Walter Bonatti pubblicati sulle pagine di Epoca – a casa arriva oltre al Corriere dei Piccoli –. Per me, il reporter rappresentava la figura dell’avventuriero, sempre in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi lontani e sconosciuti. Pensavo, allora, che l’avventura fosse possibile solo attraverso una macchina fotografica. E fantasticando sui mondi da esplorare, sulle mie avventure, ipotizzavo di essere un fotografo».
Il tuo primo reportage?
«A Londra, quando, finito il lavoro per pagarmi l’affitto, cercavo di fotografare la vita di allora. Era il 1975 e ci fu un fatto di cronaca al ristorante Spaghetti House in Knightsbridge. Una rapina si trasformò, con l’arrivo della polizia, in un assedio durato cinque giorni. Molti ostaggi erano camerieri italiani. Mi intrufolai lì, in mezzo, tra i cronisti. Feci degli scatti durante la liberazione.
La mattina dopo andai a fotografare i detenuti durante il trasferimento in tribunale. Le stampe di quel lavoro me le chiese, tempo dopo, la produzione del film che Giulio Paradisi avrebbe girato proprio su quei fatti di cronaca – uno degli attori coinvolti era Nino Manfredi –. Servivano per ricostruire parte delle scene. Non mi furono mai pagate né restituite. Tra i primi lavori, mi dedicai a documentare gli esordi del movimento punk alla fine degli anni Settanta. Erano antagonisti degli skin heads e il loro punto di ritrovo, solitamente il sabato, era la strada più famosa di quegli anni, King’s Road a Chelsea».
Sei stato tra i primi fotografi a entrare in Afghanistan, come ci riuscisti?
«Nel 1980, dopo l’invasione sovietica, entrai clandestino attraverso il Pakistan. In India incontrai dei politici afghani fuoriusciti che stavano a New Delhi. Attraverso loro, arrivato a Peshawar, mi misi in contatto con un gruppo di liberazione dell’Afghanistan. Mi aiutarono e poco dopo insieme a dei guerriglieri mujahideen entrai
clandestinamente. Rimasi con loro tre mesi e attraversammo il Paese camminando per 1.200 chilometri».
Com’è stato l’impatto con la guerra?
«All’inizio, molto difficile. Il rischio era alto per tante ragioni. L’incomprensione della lingua, per esempio, complicava non poco la mia giornata. Poi, pian piano mi sono abituato e ho cominciato a vedere le cose e a vivere quotidianamente un’esperienza che ripeterei anche domani per ciò che mi ha dato».
È vero che alcune tue foto sono nell’archivio del Pentagono?
«Sì, perché il lavoro sull’Afghanistan lo vendetti, tra gli altri, a Life.
E loro inviarono delle immagini al Pentagono per avere conferma che, nelle foto da me realizzate, i soggetti fossero effettivamente i primi soldati russi morti in battaglia dopo la Seconda guerra mondiale».
Se un ragazzo avesse il desiderio di fare il reporter, cosa gli diresti?
«È da tempo, ormai, che non incoraggio più nessuno a intraprendere questa professione. In Italia e all’estero la situazione è la stessa.
Lavorano in pochi. Con le redazioni non si collabora più, se non per cifre ridicole. Ormai le rare volte che ti propongono un lavoro da realizzare, fosse anche una storia di copertina, la prima cosa che ti dicono è che non possono pagarti, se non cifre irrisorie, spese comprese.
A un mio caro amico che vive a Parigi, membro della defunta agenzia SIPA Press, le foto di archivio, gli vengono pagate 98 centesimi l’una. Alfred, un bravissimo fotoreporter sempre in prima linea, tra l’altro ferito gravemente in Cecenia, rapito per due mesi in Libano, ferito al Cairo durante la primavera araba, mi ha mostrato il suo rendiconto mensile di centocinquantotto euro».
Il mondo ha ancora bisogno di fotografi? Di qualcuno che racconti quello che accade?
«Il mondo ha bisogno di chi fa informazione e sono in tanti che vorrebbero farla seriamente. Purtroppo, sono i giornali che hanno smesso di farla. La mia foto del marine seduto sul divano con alle spalle i ritratti dei tre regnanti sauditi, i Saud, la scattai venticinque anni fa durante la prima guerra del Golfo. Bastava quella per
raccontare l’intera vicenda: gli Stati Uniti furono chiamati a salvaguardare gli interessi dell’Arabia Saudita, ancora oggi l’alleato privilegiato, nonostante sia il maggior sponsor delle organizzazioni islamiche
integraliste e non rispetti i diritti umani. È un’immagine chiara, immediata, risolutiva. Non fu mai pubblicata, se non dopo anni, per la copertina di un mensile dedicato alla guerra. Oggi sono convinto che vi sia l’intenzione di non mettere le persone nella condizione di avere un pensiero critico. La stessa fine è stata riservata al mio progetto sul coma – nemmeno quello l’hanno mai voluto pubblicare.
Di fronte a un fatto sociale che può capitare a chiunque, alla necessità di far capire il peso di questa condizione e ciò che accade nella vita di una famiglia che, fino poche ore prima, viveva serenamente, tutto rimane bloccato perché, quando lo mostro alle redazioni, mi dicono che è un tema triste. Oggi, il giornale non fa più informazione, ma principalmente vende spazi pubblicitari. Io, azienda che acquisto la pagina di
un giornale, non ho nessun interesse a veder accostata l’immagine della mia bottiglia di champagne alla foto di un bambino che muore in Africa. È l’inserzionista che decide».
Quali sono le regole di un buon fotoreporter?
«Prima di tutto l’umiltà. Bisogna essere umili e capire quali sono le esigenze delle persone che incontri. Poi, bisogna aver chiaro che si è dei giornalisti con al collo la macchina fotografica. Molti l’hanno dimenticato, smettendo di raccontare. Realizzano, invece, delle belle fotografie nel tentativo di vincere dei premi. Con la conseguenza che si lavora per i premi e non per i lettori».
È vero che hai vinto due World Press Photo e non avresti voluto vincerli?
«Sì. Partecipai due volte. Nel 1994 l’Observer Magazine mi pubblicò il lavoro sulla Palestina dicendomi che era il miglior reportage che avevano visto negli ultimi dieci anni. Mi dissero di mandarlo al concorso – io non sapevo nemmeno come fare –. Presa visione del regolamento, insieme a quello, inviai anche il lavoro sui matrimoni napoletani.
Mi diedero il premio per i matrimoni e non per la Palestina. L’anno successivo, avevo pubblicato altri due lavori più ampi sulla Palestina.
Mandai quello pubblicato dal magazine della Frankfurter Allgemeine e il reportage sul Palio di Siena. Manco a dirlo, premiarono il Palio.
Ma come, avevo le foto degli agenti dell’intelligence per gli affari interni di Israele, lo Shin Bet, che arrestavano dei palestinesi. Cosa che nessuno aveva mai fatto. Da quella volta non concorsi più».
Di Giovanni Pelloso
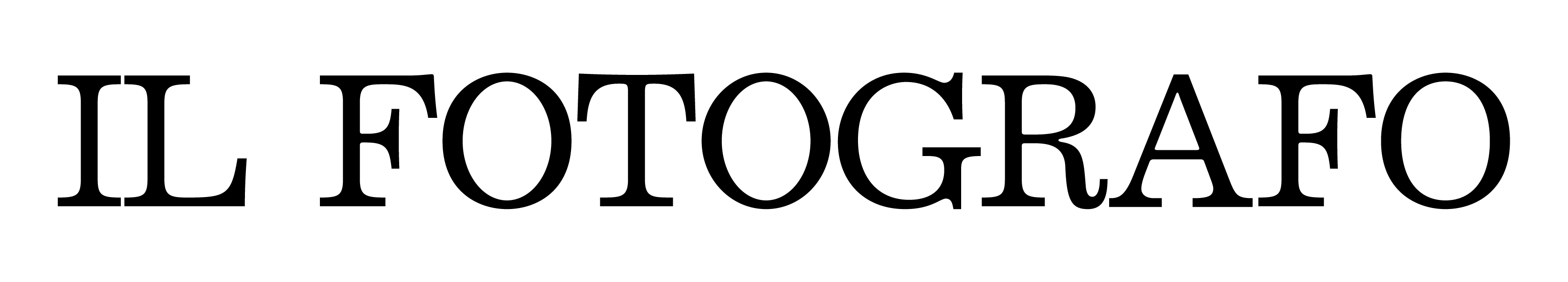
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI











GRANDE FRANCESCOOO