Sono tante le storie sommerse, cancellate o negate: Ayana V. Jackson affida al proprio autoritratto di donna afroamericana l’identità e la dignità di tutte quelle donne della diaspora africana che l’hanno preceduta da una parte e dall’altra dell’Oceano Atlantico. La fotografia si offre al lettore come scrittura visiva di un romanzo epico dalla grande forza evocativa. Una comunicazione visiva, la sua, capace di stimolare riflessioni utili per una rilettura delle vicende umane.
Suggestioni per le memoria collettiva
Scrivere con la luce è un modo per ricodificare il rapporto profondo con la parola, sia della tradizione orale che di quella scritta. Lo è certamente per Ayana Vellissia Jackson che si laurea in Sociologia prima di scegliere la professione di fotografa e filmmaker. Proviene da una famiglia con un albero genealogico che vanta la discendenza da Leah Arthur Jones, membro del ramo fondatore di Lawnside, primo insediamento nero del New Jersey. Un clan importante che ha avuto ruoli decisivi nella lotta per l’affermazione dei diritti civili della comunità afroamericana. Per lei, quindi, partire dalla storia, attraverso la fotografia d’archivio, è un passaggio cruciale per confrontarsi con il presente, smascherando bugie e vuoti di memoria di un intero Paese. Una storia di cui ci parla anche la scrittrice statunitense Toni Morrison, soprattutto in quel romanzo struggente che è Amatissima (Beloved) dove, scarnificando i sentimenti, è descritto lo status della donna/schiava nera alla mercé dell’uomo bianco, oggetto di soprusi e di violenze fisiche e psichiche negli anni a ridosso della guerra di secessione americana.


Wild like the wind, 2015 Courtesy of the Artist and Mariane Ibrahim Gallery
Ribaltamenti di significato
Nell’analizzare l’impatto dello sguardo coloniale sulla storia della fotografia, Ayana V. Jackson ricorre allo spazio psicologico ed emozionale del proprio corpo. Indossa indifferentemente gli abiti delle regine europee del XVI secolo e quelli dei rituali africani fortemente connessi alla spiritualità e alla magia. Non mancano nemmeno gli abiti di foggia tardo settecentesca e ottocentesca, vista la sua consapevolezza riguardo alla moda: non è solo apparenza, può incarnare anche il gesto della ribellione, diventandone il manifesto più evidente. È così in Tignon, anche quando indossa il copricapo femminile usato negli ultimi due secoli a New Orleans: un foulard che ricorda il gele dell’Africa occidentale, avvolto come un turbante intorno alla testa e ancora oggi utilizzato nella città del blues. La sua storia è legata alla legge promulgata in Louisiana alla fine del XVIII secolo – la Tignon Laws, approvata nel 1786 sotto l’amministrazione del governatore Esteban Rodriguez Miró – che imponeva alle donne di colore, creole e indigene, di coprire la folta capigliatura quando erano in pubblico per non attirare l’attenzione dei maschi bianchi. La loro bellezza era percepita come una minaccia per le donne bianche.

Molti storici considerano questa forma di controllo un modo per declassare visibilmente, oltre che simbolicamente, le donne di colore. Ribaltandone il significato, la fotografa associa questo accessorio di stile a un concetto di dignità. Nel suo sguardo e nella postura c’è la stessa dignità, lo stesso orgoglio nell’affermazione di sé che affiora nei volti delle persone ritratte dal fotografo Hugh Mangum (1877-1922), bianco e antirazzista che sfidò le leggi segregazioniste di Jim Crow, attraversando tra il 1897 e il 1922 gli stati più conservatori e segregazionisti degli Stati Uniti d’America come la Carolina del Nord e la Virginia. Con il suo studio portatile ha consegnato alla storia un frammento di memoria a chiunque si poneva davanti al suo obiettivo, senza pregiudizi né di razza e né di classe. In particolare, l’affrancamento della donna afroamericana e il suo ruolo di donna libera, benché in una società dalla struttura patriarcale, è un tema particolarmente caro ad Ayana V. Jackson, come è evidente nelle sue opere fotografiche, tra cui le serie Archival Impulse, Intimate Justice, Dear Sarah, The Becoming Subject, To Kill or Allow to Live. Proprio il doppio autoritratto Prototype/Phenotype (2013), in cui indossa la blusa bianca di trine e ha i capelli raccolti in uno chignon, è stato scelto come copertina del romanzo storico di Igiaba Scego La linea del colore (Bompiani 2019). Nella finzione letteraria la protagonista Lafanu Brown è una pittrice americana di pelle nera che nella seconda metà del XIX secolo sceglie Roma come città d’adozione. La sua figura è ispirata alla biografia di due donne straordinarie vissute in carne e ossa: la scultrice Mary Edmonia Lewis (1844-1907), prima afroamericana a raggiungere un riconoscimento internazionale nel campo della scultura e l’attivista per i diritti umani e il suffraggio femminile Sarah Parker Remond (1826- 1894), che a soli 16 anni tenne il suo primo discorso contro la schiavitù. Anche Jackson è un’artivista per la quale la fotografia non è solo un mezzo per dare voce alle storie del passato, ma una testimonianza che offre spunti di riflessione al di là della componente seduttiva dell’estetica, anche quando ripercorre le “memorie acquatiche” – da Olokum a Mame Coumba Bang, da Kianda a Drexciya, da Yemanja a Mami Wata – legate alle radici più profonde della cultura africana.
di Manuela De Leonardis

Tignon, 2016, Courtesy of the Artist and Mariane Ibrahim Gallery
Molti storici considerano questa forma di controllo un modo per declassare visibilmente, oltre che simbolicamente, le donne di colore. Ribaltandone il significato, la fotografa associa questo accessorio di stile a un concetto di dignità. Nel suo sguardo e nella postura c’è la stessa dignità, lo stesso orgoglio nell’affermazione di sé che affiora nei volti delle persone ritratte dal fotografo Hugh Mangum (1877-1922), bianco e antirazzista che sfidò le leggi segregazioniste di Jim Crow, attraversando tra il 1897 e il 1922 gli stati più conservatori e segregazionisti degli Stati Uniti d’America come la Carolina del Nord e la Virginia. Con il suo studio portatile ha consegnato alla storia un frammento di memoria a chiunque si poneva davanti al suo obiettivo, senza pregiudizi né di razza e né di classe. In particolare, l’affrancamento della donna afroamericana e il suo ruolo di donna libera, benché in una società dalla struttura patriarcale, è un tema particolarmente caro ad Ayana V. Jackson, come è evidente nelle sue opere fotografiche, tra cui le serie Archival Impulse, Intimate Justice, Dear Sarah, The Becoming Subject, To Kill or Allow to Live. Proprio il doppio autoritratto Prototype/Phenotype (2013), in cui indossa la blusa bianca di trine e ha i capelli raccolti in uno chignon, è stato scelto come copertina del romanzo storico di Igiaba Scego La linea del colore (Bompiani 2019). Nella finzione letteraria la protagonista Lafanu Brown è una pittrice americana di pelle nera che nella seconda metà del XIX secolo sceglie Roma come città d’adozione. La sua figura è ispirata alla biografia di due donne straordinarie vissute in carne e ossa: la scultrice Mary Edmonia Lewis (1844-1907), prima afroamericana a raggiungere un riconoscimento internazionale nel campo della scultura e l’attivista per i diritti umani e il suffraggio femminile Sarah Parker Remond (1826- 1894), che a soli 16 anni tenne il suo primo discorso contro la schiavitù. Anche Jackson è un’artivista per la quale la fotografia non è solo un mezzo per dare voce alle storie del passato, ma una testimonianza che offre spunti di riflessione al di là della componente seduttiva dell’estetica, anche quando ripercorre le “memorie acquatiche” – da Olokum a Mame Coumba Bang, da Kianda a Drexciya, da Yemanja a Mami Wata – legate alle radici più profonde della cultura africana.
di Manuela De Leonardis
Ayana Vellissia Jackson

Livingston, New Jersey, Stati Uniti, 1977. Si laurea in Sociologia allo Spelman College di Atlanta. Tra le mostre recenti: 2020 – Riffs and Relations: African American Artists and the European Modernist Tradition, The Phillips Collection, Washington; 2019 – Take Me to the Water, Mariane Ibrahim Gallery, Chicago (personale), Dear Sarah, David Klein Gallery, Detroit (personale), Smart to the Core: Embodying the Self, Smart Museum of Art, Chicago. Le sue opere fanno parte di collezioni quali Princeton University Art Museum, Princeton; Museum of African Contemporary Art Al-Maaden, Marrakech; The Museum of Contemporary Photography, Chicago; The JP Morgan Chase Art Collection, New York; National Gallery of Victoria, Melbourne. Vive e lavora tra New York, Parigi e Johannesburg.
Puoi trovare l’articolo completo su IL FOTOGRAFO #323, ora in edicola, oppure in versione digitale qui!

© Manuela De Leonardis
Livingston, New Jersey, Stati Uniti, 1977. Si laurea in Sociologia allo Spelman College di Atlanta. Tra le mostre recenti: 2020 – Riffs and Relations: African American Artists and the European Modernist Tradition, The Phillips Collection, Washington; 2019 – Take Me to the Water, Mariane Ibrahim Gallery, Chicago (personale), Dear Sarah, David Klein Gallery, Detroit (personale), Smart to the Core: Embodying the Self, Smart Museum of Art, Chicago. Le sue opere fanno parte di collezioni quali Princeton University Art Museum, Princeton; Museum of African Contemporary Art Al-Maaden, Marrakech; The Museum of Contemporary Photography, Chicago; The JP Morgan Chase Art Collection, New York; National Gallery of Victoria, Melbourne. Vive e lavora tra New York, Parigi e Johannesburg.
Puoi trovare l’articolo completo su IL FOTOGRAFO #323, ora in edicola, oppure in versione digitale qui!
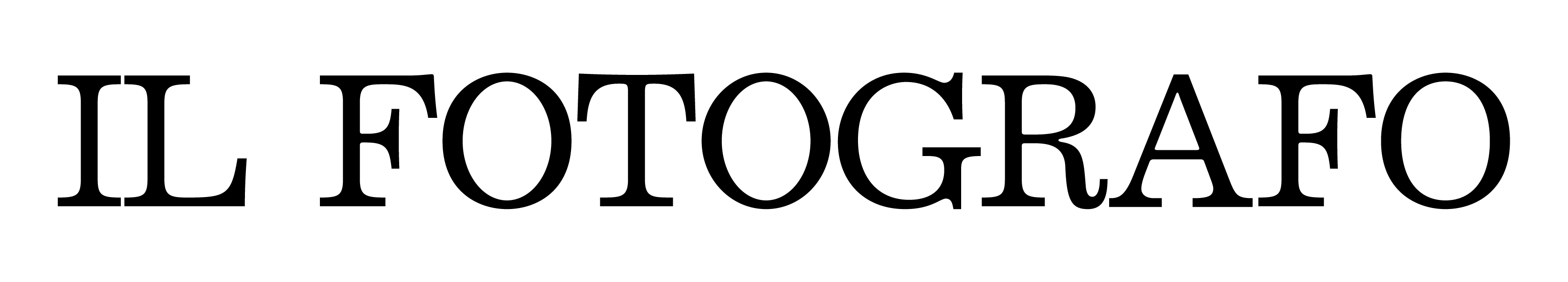
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





