Antoine D’Agata: rude, potente, diretto. La sua missione è difendere la propria unicità, rifiutando le regole e il pensiero di massa
Non è semplice definire con le parole il complesso mondo di Antoine D’Agata. Se Dante Alighieri nel XIV secolo aveva aperto alla nostra immaginazione le porte dell’inferno, narrandoci dei tormenti e delle sofferenze a cui l’uomo era destinato, l’artista francese l’ha fotografato, per ricordarci che a volte il male non è poi così lontano. Seppur allievo di grandi maestri come Nan Goldin e Larry Clark in una delle migliori scuole al mondo come l’ICP di New York e membro dell’agenzia Magnum, racconta di non riconoscersi in nessun tipo di stile fotografico e di andare contro ogni possibile influenza culturale. Lontano dall’ipocrisia del politicamente corretto, per anni è stato a contatto diretto con le contraddizioni della nostra natura nel tentativo di comprendere nel profondo il significato dell’esistenza.
Intervista a Antoine D’Agata
Cosa significa per te fotografare?
«In tutta onestà non sono mai stato molto interessato alla cultura fotografica in sé. Questa per me non è altro che un linguaggio e uno strumento molto efficiente per raccontare e interagire con ciò che veramente mi attrae, ovvero il mondo e la vita degli uomini che lo popolano. Senza alcun dubbio, per potermi esprimere attraverso la fotografia ho dovuto studiare la sua storia e la tecnica, capirla, esplorarne i limiti e il potenziale narrativo, ma non sono mai riuscito a rispettarla e ad amarla fino in fondo. Tutto ciò che per me importa è dare sfogo alle mie intime necessità».
La fotografia, dunque, la intendi come una lente d’ingrandimento con cui scandagliare l’esistenza umana.
«Esattamente. Per più di dodici anni mi sono completamente immerso in un folle viaggio ai confini della notte più profonda. Lì ho percepito che avrei potuto creare, inventare, andare alla ricerca di nuove prospettive e la fotografia è stato lo strumento che mi ha dato questa possibilità. In particolar modo credo che nella nostra epoca, caratterizzata da una società così violenta e alienante, un mezzo come la fotografia sia in grado di cambiare il modo di relazionarsi tra le persone».
In un mondo costantemente connesso a Internet, dove l’immagine di un avvenimento può fare il giro del mondo in tempo reale, ti può portare a credere che la fotografia, con la sua rapidità e facilità di comprensione, sia l’arte che incarni al meglio i valori del nuovo millennio?
«Ritengo che la fotografia sia il linguaggio che più in assoluto rappresenti al meglio la nostra epoca contemporanea. Soprattutto le nuove generazioni hanno bisogno di qualcosa di più delle parole e l’immagine ha colmato questa loro necessità. Queste, senza dubbio sono diventate il linguaggio universale per eccellenza. Negli ultimi vent’anni c’è stata una sorta di fruizione malata, a mio parere, da parte della popolazione di massa dell’utilizzo della fotografia, soprattutto in funzione dei social network. Tuttavia, mi riconosco molto di più in questo atteggiamento, dove le persone rincorrono, fotografano e condividono le loro paure e i loro desideri, piuttosto che nell’approccio dei miei colleghi professionisti».
Un tuo lavoro che mi ha particolarmente colpito è Psicogeographie , soprattutto perché risulta apparentemente molto diverso dai tuoi soliti progetti. Ce ne vuoi parlare?
«Se dovessi definire con una parola il mio lavoro penso che quella più adatta sia schizofrenico. Nella nostra società convivono due tipologie di violenza. La prima più strettamente legata ai nostri impulsi, alla nostra parte oscura, come gli eccessi, la tossicodipendenza, le perversioni sessuali, il crimine; l’altra, invece, scaturisce da ragioni economiche e politiche. Questo progetto nello specifico si può inserire in quest’ultima categoria dove ho cercato, con distanza e freddezza, di documentare il cambiamento urbano di alcune zone della mia città, Marsiglia, e di come questa trasformazione abbia influito sugli abitanti. Una cosa molto importante da evidenziare è che questo progetto nasce da una commissione pubblica pagata dallo stato francese. Ho fotografato le persone che erano state espulse dai loro quartieri d’origine per via delle riqualificazioni urbane e successivamente ho documentato il cambiamento di queste zone. Una volta in studio ho ripopolato questi nuovi quartieri reinserendo, attraverso la post-produzione, i ritratti realizzati precedentemente alle persone allontanate in un’atmosfera di totale estraneazione. In tutta la mia carriera è stata la prima volta che ho utilizzato il fotomontaggio, mischiando realtà e finzione e ottenendo così un vero lavoro di propaganda, al fine di svelare l’impatto e le vere motivazioni dietro questi processi di rinnovamento urbano».
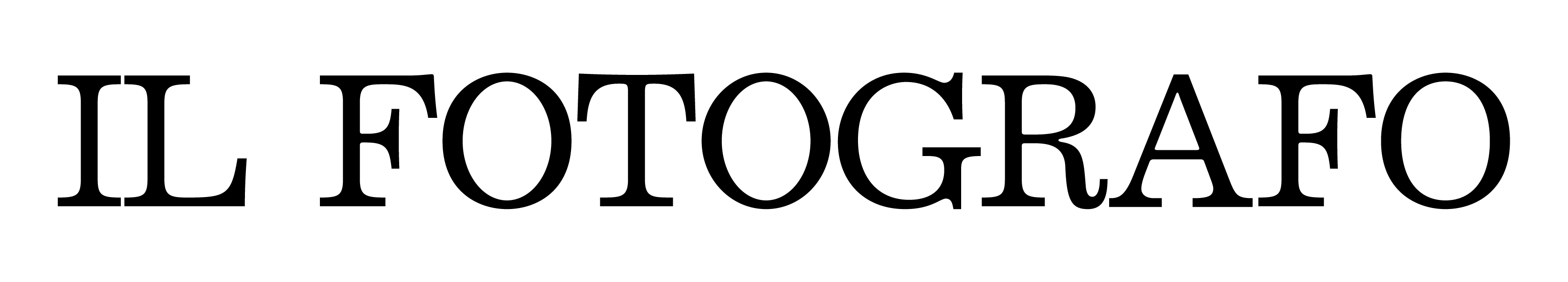
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





