La fotografia è un mestiere da vivere con ironia
Occhi vispi incorniciati da occhiali tigrati, treccia bianca, frangetta corta da ragazzina, Maria Vittoria Backhaus non passa facilmente inosservata. Il suo stile inconfondibile oscilla tra il monacale e il birichino. Un po’ come le sue fotografie: essenziali e barocche, surreali e rigorose, con qualche punta di bizzarro e kitsch. Schietta, ironica e caciarona, per sua stessa ammissione, si rivela senza filtri in questa intervista, raccontando una carriera, ma sarebbe meglio dire una vita, costellata di esperienze insolite e incontri fuori dal comune.
La fotografia è un mestiere da vivere con ironia. Intervista a Maria Vittoria Backhaus
Come ti avvicini alla fotografia?
«Il mio percorso inizia all’Accademia di Belle Arti di Brera dove studio Scenografia contro il volere di tutta la famiglia. Più che le lezioni, frequentavo il bar Jamaica, ritrovo di grandi fotografi, che poi sono diventati amici, come Uliano Lucas, Mario Dondero e Ugo Mulas. Io ero la più piccola della compagnia e osservavo questi maestri che lavoravano ai propri progetti senza alcuna consapevolezza di fare arte; nemmeno Mulas, il più raffinato e meno reporter di tutti, aveva questa idea. Ognuno si preoccupava di documentare la realtà e di fare il fotografo. La parola artista non aveva alcuna attinenza. Poi mi sono sposata molto giovane, a ventun anni, con un giornalista e girando assieme a lui ho scoperto la passione per il reportage che si coniugava perfettamente con il mio interesse verso le questioni sociali e la politica».
Come hai affrontato i primi progetti?
«Per il primissimo reportage ambientato in un paesino sperduto della Sicilia dove si viveva ancora senza fogne, come nell’Ottocento, mi sono fatta addirittura prestare la macchina fotografica! Non avevo molti mezzi, a ventitré anni poi ho divorziato dal mio primo marito, perdendo ogni comunicazione con la mia famiglia per qualche anno. A quel punto mi ritrovavo a essere una giovane donna con un futuro da costruire da sola. Volevo lavorare per mantenermi e il reportage era la mia passione, ma le difficoltà che incontravo talvolta erano enormi. In altri casi, si trattava di questioni ridicole. Alcuni giornali non mi davano commissioni solo per evitare di pagare una stanza d’albergo in più, visto che il fotografo di solito dormiva con il giornalista inviato».
Cosa significava essere una fotografa donna a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta?
«Essere donna era dura. Letizia Battaglia, per esempio, andava sempre in giro con un uomo, Santi Caleca, prima, e Franco Zecchin, in seguito. Lavoravano in coppia, altrimenti come avrebbe potuto raccontare la Sicilia in quel modo? Per un periodo ho fatto reportage con Guido Vergani, grande redattore del Tempo Illustrato . Ricordo una 500 scassata presa in affitto, un viaggio in Sardegna e una mia scenata di pianto per riuscire a ottenere il permesso di fotografare dei battaglioni di militari arrivati sull’isola da Bolzano. In quel caso l’essere donna fu una risorsa (ride)».
In seguito ti dedichi al reportage industriale.
«Andavo nelle fabbriche da sola, senza assistente, con una Hasselblad pesantissima al collo. Guidavo di notte, facevo tutto il servizio in fabbrica e poi, sempre di notte, sviluppavo e stampavo in camera oscura. Lavoravo per riviste come Successo e Tempo Illustrato e nonostante la fatica, soprattutto fisica, mi sentivo gratificata dalla possibilità di avere accesso a un mondo che solitamente non veniva mostrato, quello delle fabbriche di enormi dimensioni, con diecimila operai intenti a lavorare, in condizioni non sempre ottimali. Come la volta in cui, nella fabbrica della Marzotto, mi sono imbattuta, assieme alla bravissima giornalista Carla Ravaioli, in una sala di stiratrici dove l’umidità creata dal vapore era così forte che si era formata una sorta di pulviscolo tale da rendere lo spazio invivibile e da danneggiare completamente tutte le mie pellicole»
Come evolve il tuo linguaggio in questi anni di intenso lavoro?
«Che si trattasse di still life, fotografia d’arredamento o servizi di moda, amavo sperimentare e creare set complicati che richiedevano una lunga ricerca, la parte che preferivo. Le mie fotografie erano molto costose da realizzare e mi piaceva inserire il prodotto all’interno di un racconto, partire da un’idea che a sua volta mi veniva suggerita dal cinema, dall’arte e soprattutto dall’attualità, da ciò che stava accadendo nel mondo. É sempre stata quella la principale fonte d’ispirazione. Un altro aspetto che mi piaceva era la condivisione, il fatto di lavorare in sala posa con una squadra composta da tante persone con cui si creavano confronti, sinergie e amicizie di una vita, come quella con Sergio Colantuoni, con il quale ho lavorato in simbiosi per tanti anni al settimanale Io Donna , quando il direttore moda era Bruna Rossi. Ad accomunarci, oggi come allora, è l’ironia, la leggerezza di non prendersi troppo sul serio».
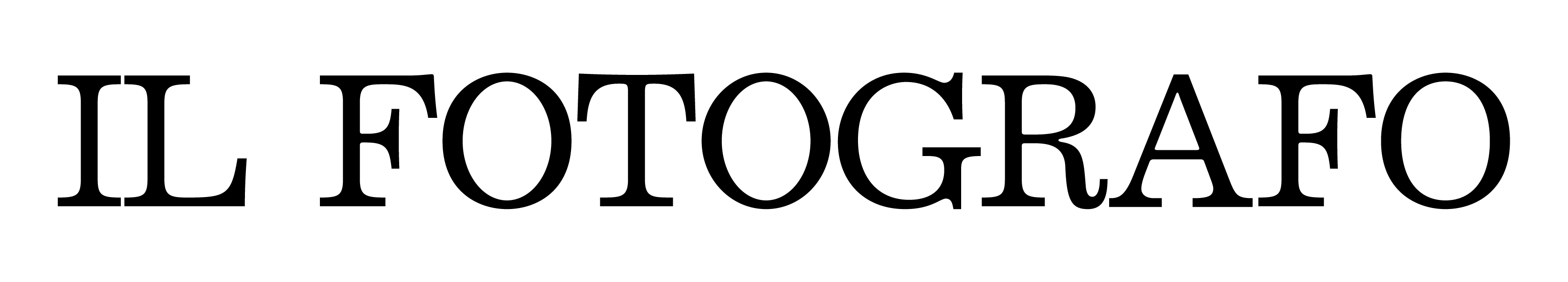
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





