Charles Fréger
La mostra retrospettiva, ospitata negli eleganti spazi dell’Armani/Silos, documenta l’estensione e la profondità della ricerca antropologica del fotografo francese.
In età classica il termine fabula, dal verbo latino fari, stava a indicare un racconto orale di narrazioni fantastiche, come leggende e miti allegorici, che narravano la vita e le gesta degli dei. Da queste nascevano tradizioni e simboli rituali che si tramandavano di paese in paese e di generazione in generazione, affondando le proprie radici nella primitiva sapienza dei popoli. Non a caso, la notevole opera di Charles Fréger può essere definita come una sorta di fabula visiva. Nelle sue immagini il fotografo francese, indagando il rapporto tra l’idea di comunità e i suoi codici di abbigliamento intesi come emblema sociale, diffonde storie, ritualità e simboli delle varie collettività in giro per il mondo. Un approfondimento antropologico quello di Fréger che richiama, nella sua idea di catalogazione, l’antesignana opera del fotografo tedesco August Sander Face of Our Time (1929) – un ritratto dell’allora società della Repubblica di Weimar, attraverso la rappresentazione archetipa dell’individuo in classi sociali, professioni e mestieri –. Tuttavia, l’opera di Fréger non si limita a una classificazione di prototipi, ma il suo interesse si spinge più in profondità, ovvero al modo in cui gli uomini affrontano paure profonde ed esprimono il bisogno o la volontà di appartenere. Il suo lavoro costruisce una codificazione progressiva di segni ed evidenzia il potere degli abiti come mezzo di comunicazione non verbale. Ciò che rende ancora più sorprendente l’opera di Fréger è il suo coinvolgimento con i soggetti, dove talvolta è lui stesso che prende parte attiva al travestimento per comprendere appieno ciò che sta studiando. Fino al 24 marzo gli spazi dell’Armani/Silos di Milano ospitano una sua grande retrospettiva con oltre duecentocinquanta immagini. Abbiamo avuto modo di approfondire il suo pensiero con l’artista al quale abbiamo rivolto alcune domande.
Intervista a Charles Fréger
Quando e perché hai scelto la fotografia come forma espressiva?
«Ero studente alla Rouen School of Art. Mi ero iscritto a Belle Arti perché dipingevo, ma è lì che ho cominciato attivamente a fare fotografia. Non è stata l’ammirazione per il lavoro di altri fotografi a spingermi verso questa direzione. Le mie fonti d’ispirazione, infatti, erano Mondrian, Velázquez, Van Eyck, Vermeer, Warhol e Bacon. E la mia fotografia guardava alla pittura. Peraltro, ho iniziato a fotografare con il ritratto per poi interessarmi al concetto di comunità e di uniforme e infine, al ritratto in serie affrontato con il rigore di un pittore classico e concettuale».
Le tue fotografie sono rappresentazioni poetiche di tradizioni e riti pagani che caratterizzano gruppi sociali in tutto il mondo, dall’Europa all’Asia e dall’Africa all’America. Quali sono gli aspetti che ti affascinano di più di questi fenomeni antropologici? Che cosa desideri trasmettere a chi osserva i tuoi ritratti?
«L’idea di fotografare queste tradizioni, che hanno talvolta radici pagane, è partita dedicandomi a serie fotografiche in cui l’uniforme o il vestito erano elaborati con materiali preziosi, come il panno di lana, il velluto, la piuma, il ricamo, i bottoni dorati. Intorno al 2010, ho sentito il bisogno di spingere le mie ricerche verso comunità in cui il costume indossato invece, era più grezzo, più radicale. È così che ho fotografato Wilder Mann. È una serie bulimica in cui ho trovato molta energia. Mi sono sentito vicino al soggetto, un po’ come se io stesso avessi qualcosa degli uomini-orso che fotografavo in tutta Europa. Wilder Mann mi ha spinto ad andare ancor più lontano, a proseguire la mia ricerca in ogni parte del mondo.
Quelle che ritraggo sono tradizioni vive, e non in via di sparizione come a volte qualcuno immagina. È solo che molto spesso queste mascherate si svolgono lontano dalle grandi città e dai media, il che può indurre a credere che siano rare. Ne esistono molte e generano espressioni artistiche sperimentali in termini di costumi e di abiti che sfidano la moda, dando prova di libertà e radicalità».
Fabula è la sua prima mostra nei prestigiosi spazi di Armani/Silos a Milano, dove c’è una collezione permanente di vestiti creati da Giorgio Armani dal 1980 a oggi. Sei d’accordo sul fatto che la moda e la sua industria, con i suoi simboli, potrebbero essere considerate una sorta di moderna evoluzione delle storie e dei riti che racconti nelle tue opere?
«Evoluzione, non credo. La moda è una produzione parallela. Esiste molto spesso indipendentemente. Per me la moda è l’espressione dell’identità di uno stilista e della sua visione del mondo. Mentre i costumi che fotografo in queste comunità sono il frutto di una sedimentazione di sapere, di tradizioni e di usanze, riprodotta da un’intera comunità. È l’identità di un gruppo e della propria cultura, non soltanto quella di uno stilista di moda. Che poi i due mondi si guardino, si ammirino e s’ispirino, è un’altra questione che mi pare veramente interessante. La moda si ritualizza e dà vita a varie fedi».
Questo e molto altro sul nuovo numero de IL FOTOGRAFO in edicola e disponibile online
Immagine in evidenza Queens of Cebu, Philippine islands, 2011 Photo by Charles Fréger
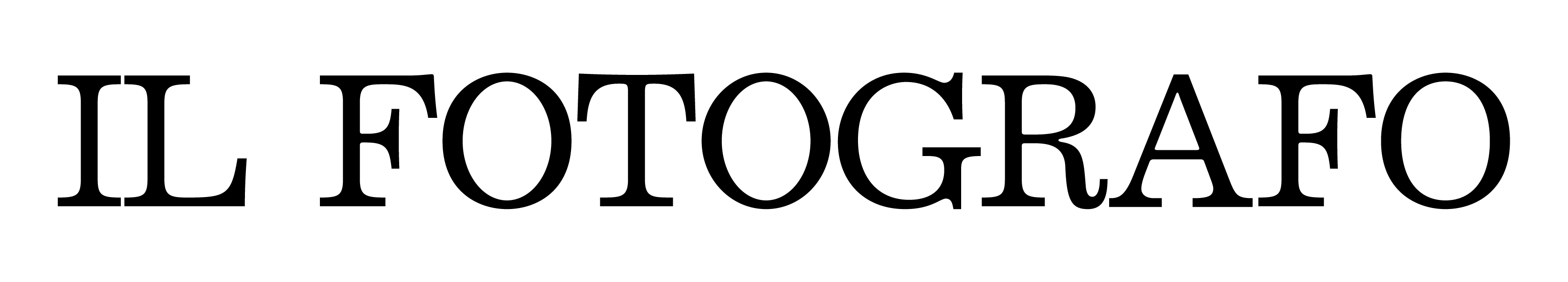
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





