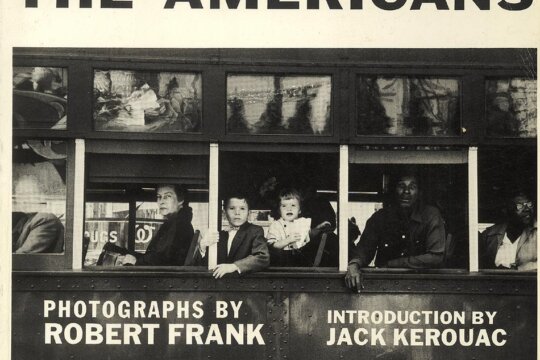di Giada Storelli
Alessandro Grassani ha scelto al caos dei grandi eventi internazionali la quiete del lavoro in solitaria
Per lui la fotografia è uno scambio umano, una relazione con il soggetto basata sul dare e il ricevere.
Il suo scopo è donare la possibilità alle persone di avere una voce e alle loro storie di essere raccontate. Le sue fotografie possiedono la forza della verità e l’armonia della composizione. Distante dalla teatralità del dramma, ricorda all’osservatore il rispetto del dolore.

© Alessandro Grassani
Le storie che racconti sono dei veri e propri approfondimenti giornalistici. Perché hai scel- to la fotografia come mezzo di espressione?
«Ho scelto la fotografia perché mi dà la possibilità di vivere in prima persona le storie che voglio raccontare. Per arrivare a documentare nell’intimo la realtà delle persone ogni volta ho bisogno di condividere il più possibile con loro, di guardarli negli occhi, di avere uno scambio umano. Ho sempre osservato con grande interesse i progetti dei fotografi del National Geographic, le immagini di guerra di James Nachtwey e gli sterminati paesaggi di Ansel Adams».
«Ho scelto la fotografia perché mi dà la possibilità di vivere in prima persona le storie che voglio raccontare. Per arrivare a documentare nell’intimo la realtà delle persone ogni volta ho bisogno di condividere il più possibile con loro, di guardarli negli occhi, di avere uno scambio umano. Ho sempre osservato con grande interesse i progetti dei fotografi del National Geographic, le immagini di guerra di James Nachtwey e gli sterminati paesaggi di Ansel Adams».
Qual è stato il tuo primo progetto fotogiornalistico?
«Il mio primo, vero, progetto sul campo è stato Journey to Iran ed è durato dal 2005 al 2009, anche se avevo già avuto l’occasione di lavorare nel 2003 a Bam, una piccola città colpita da un terremoto. È stato un periodo molto particolare; era da poco salito al potere Ahmadinejad e la tensione internazionale era molto alta per via della crisi nucleare. Tuttavia, quello che volevo raccontare erano le varie sfaccettature della società iraniana, diversa dallo stereotipo di fanatismo religioso che i media internazionali dipingevano. Nel progetto ho voluto focalizzare la mia attenzione sulle categorie avverse al regime, dai giovani, che guardavano con interesse all’Occidente, alle minoranze etniche per raccontare la loro quotidianità nonostante le pressioni governative e la complessa diversità sociale del Paese. Il progetto con il tempo si è rivelato una vera e propria narrazione in immagini dell’assetto geopolitico dell’Iran».

«Il mio primo, vero, progetto sul campo è stato Journey to Iran ed è durato dal 2005 al 2009, anche se avevo già avuto l’occasione di lavorare nel 2003 a Bam, una piccola città colpita da un terremoto. È stato un periodo molto particolare; era da poco salito al potere Ahmadinejad e la tensione internazionale era molto alta per via della crisi nucleare. Tuttavia, quello che volevo raccontare erano le varie sfaccettature della società iraniana, diversa dallo stereotipo di fanatismo religioso che i media internazionali dipingevano. Nel progetto ho voluto focalizzare la mia attenzione sulle categorie avverse al regime, dai giovani, che guardavano con interesse all’Occidente, alle minoranze etniche per raccontare la loro quotidianità nonostante le pressioni governative e la complessa diversità sociale del Paese. Il progetto con il tempo si è rivelato una vera e propria narrazione in immagini dell’assetto geopolitico dell’Iran».

© Alessandro Grassani
Dal 2011 sei impegnato nella ricerca Environmental migrants: the last illusion.
Il progetto, distinto in quattro capitoli, riguarda i migranti ambientali, le persone costrette a fuggire dal proprio Paese in conseguenza ai cambiamenti climatici. Ci racconti gli sviluppi?
«Il progetto ha avuto inizio in Mongolia. Qualche tempo prima avevo sentito parlare di un inverno particolarmente rigido che aveva colpito il Paese e che aveva ucciso otto milioni di capi di bestiame e costretto ventimila pastori a emigrare verso la città di Ulan Bator. Quello che mi premeva capire era il destino di questi allevatori costretti a emigrare e ad abbandonare tutto a causa dei cambiamenti climatici. Pertanto, la mia idea era, innanzitutto, di documentare la vita nelle campagne condannata dall’estremo freddo per poi raccogliere le testimonianze a Ulan Bator di coloro che erano stati costretti a vivere in povertà nelle tende piantate nella periferia della città con la conseguente trasformazione dell’assetto urbano. Mentre ero impegnato nel reportage e nel confronto con i ricercatori che studiavano da tempo il fenomeno, ho compreso che questa problematica non riguardava solamente la Mongolia, ma le stesse condizioni si stavano verificando in altri Paesi. Così, subito dopo, sono partito per il Bangladesh e, negli anni successivi, ho ampliato il progetto anche al Kenya e ad Haiti, mantenendo sempre la medesima formula narrativa. Environmental migrants ha una forte struttura sia giornalistica che scientifica ed è stato prodotto, e in parte finanziato, in collaborazione con importanti associazioni internazionali. L’International Organization for Migration (IOM) ha recentemente organizzato a Parigi una mostra sul mio lavoro dal titolo Entwined Destinies: Migration, Environment and Climate Change esposta al Palais de la Port Dorée alla fine del 2015 per sensibilizzare la persone rispetto a queste tematiche».
Il progetto, distinto in quattro capitoli, riguarda i migranti ambientali, le persone costrette a fuggire dal proprio Paese in conseguenza ai cambiamenti climatici. Ci racconti gli sviluppi?
«Il progetto ha avuto inizio in Mongolia. Qualche tempo prima avevo sentito parlare di un inverno particolarmente rigido che aveva colpito il Paese e che aveva ucciso otto milioni di capi di bestiame e costretto ventimila pastori a emigrare verso la città di Ulan Bator. Quello che mi premeva capire era il destino di questi allevatori costretti a emigrare e ad abbandonare tutto a causa dei cambiamenti climatici. Pertanto, la mia idea era, innanzitutto, di documentare la vita nelle campagne condannata dall’estremo freddo per poi raccogliere le testimonianze a Ulan Bator di coloro che erano stati costretti a vivere in povertà nelle tende piantate nella periferia della città con la conseguente trasformazione dell’assetto urbano. Mentre ero impegnato nel reportage e nel confronto con i ricercatori che studiavano da tempo il fenomeno, ho compreso che questa problematica non riguardava solamente la Mongolia, ma le stesse condizioni si stavano verificando in altri Paesi. Così, subito dopo, sono partito per il Bangladesh e, negli anni successivi, ho ampliato il progetto anche al Kenya e ad Haiti, mantenendo sempre la medesima formula narrativa. Environmental migrants ha una forte struttura sia giornalistica che scientifica ed è stato prodotto, e in parte finanziato, in collaborazione con importanti associazioni internazionali. L’International Organization for Migration (IOM) ha recentemente organizzato a Parigi una mostra sul mio lavoro dal titolo Entwined Destinies: Migration, Environment and Climate Change esposta al Palais de la Port Dorée alla fine del 2015 per sensibilizzare la persone rispetto a queste tematiche».
Nell’era della fotografia realizzata con lo smartphone, cosa significa essere un reporter di professione?
«Talvolta mi interrogo sul significato di questo lavoro. Spesso le immagini degli eventi di cronaca sono scattate dalle persone coinvolte nell’avvenimento e in tempo reale caricate online. Penso che
il futuro del fotogiornalismo sia lavorare a progetti a lungo termine e indagare grandi tematiche sociali. Nel mio lavoro il momen- to bressoniano va in secondo piano per dare più importanza ai contenuti e alla struttura progettuale. Oggi il reporter di cronaca deve avere la capacità e l’istinto di immortalare ciò che gli altri non vedono e avere la lucidità, nella concitazione della circostanza, di individuare e isolare attimi significativi. A riguardo ho apprezzato molto il lavoro I veli di Aleppo di Franco Paggetti sulla guerra in Siria».
«Talvolta mi interrogo sul significato di questo lavoro. Spesso le immagini degli eventi di cronaca sono scattate dalle persone coinvolte nell’avvenimento e in tempo reale caricate online. Penso che
il futuro del fotogiornalismo sia lavorare a progetti a lungo termine e indagare grandi tematiche sociali. Nel mio lavoro il momen- to bressoniano va in secondo piano per dare più importanza ai contenuti e alla struttura progettuale. Oggi il reporter di cronaca deve avere la capacità e l’istinto di immortalare ciò che gli altri non vedono e avere la lucidità, nella concitazione della circostanza, di individuare e isolare attimi significativi. A riguardo ho apprezzato molto il lavoro I veli di Aleppo di Franco Paggetti sulla guerra in Siria».
Alessandro Grassani
Nasce a Pavia nel 1977. Si diploma in fotografia presso l’Istituto Riccardo Bauer di Milano e nella sua carriera ha collaborato con riviste come The New York Times, L’Espresso, Sunday Times e organizzazioni internazionali come Doctors of the World e International Organization for Migration (IOM). Con i suoi progetti, esposti in tutto il mondo, ha ricevuto importanti premi tra i quali il Premio Internacional de Fotografia Humanitaria Luis Valtueña, il Sony World Photography Awards e il PX3 International Awards. Nel settembre 2013 ha tenuto una conferenza a Berlino per il TEDx. Dal 2011 è insegnante alla scuola John Kaverdash di Milano al Master di fotografia documentaria.
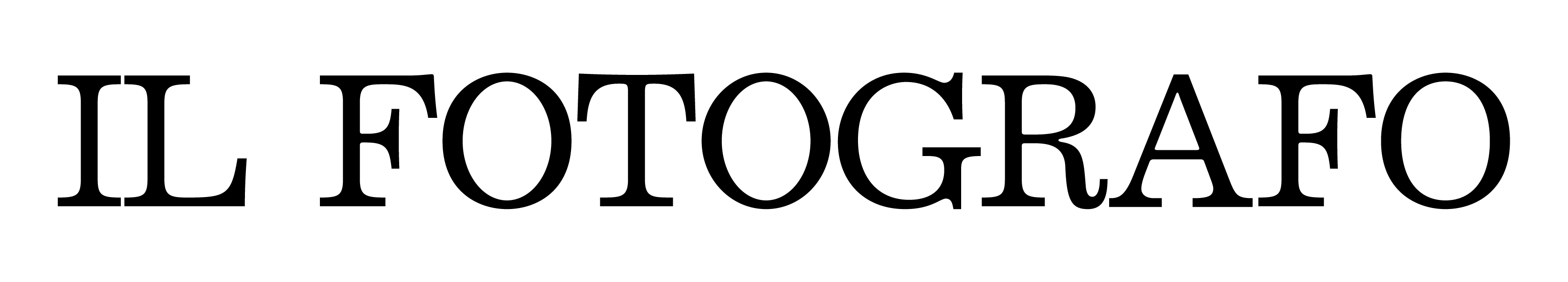
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI