Sono entrato per bere una birra. C’era un juke-box che suonava e mi sono messo a ballare con le ragazze. Ad un certo punto mi sono accorto che stavano giocando con la mia Nikon, che avevo lasciato sul tavolo: se la lanciavano l’un l’altro, scattandosi delle foto, ma era solo un gioco, a cui chiesi anch’io di partecipare per fotografare ed essere fotografato». Così Anders Petersen racconta il suo primo incontro con il mondo dolente del Cafè Lehmitz, bar di St. Pauli, il quartiere a luci rosse posto ai margini del grande porto di Amburgo e frequentato da prostitute sfiorite, tossicodipendenti, portuali, piccoli malavitosi, omosessuali, travestiti e magnaccia. Un’umanità, a prima vista sgradevole e inquietante, confinata ai margini della società e raccolta nell’unico luogo che li accettava a qualsiasi ora del giorno e della notte. Petersen subì il fascino di questo microcosmo desolato che diventò scuola di vita, palcoscenico, laboratorio e progetto della sua fotografia dal 1966 al 1968. Nello stesso periodo frequentava a Stoccolma i corsi della Fotoskola di Christer Strömholm che aveva fotografato in Poste Restante (1967) la Parigi trasgressiva degli anni Cinquanta e Sessanta e che lo influenzò insieme a Ed van der Elsken di Une histoire d’amour à Saint Germain des Près (1956). Per tre anni Petersen andò quasi ogni mese ad Amburgo, dormendo nella cucina del Cafè Lehmitz e fotografando ossessivamente il popolo tenero e disperato che passava di lì, fino a diventarne parte: «bevendo, ballando, amando, gridando, cantando» insieme a loro. Nel 1970 vi organizzò la sua prima mostra di 350 immagini appese con gli spilli alle pareti, lasciando a chi vi si riconosceva di prendersi la foto come ricordo e condivisione di quell’esperienza. Queste fotografie sfuggono a una facile estetizzazione della marginalità, non vi è compiacimento o consolazione, anzi, in alcune è evidente il lato grottesco e impudico, oscuro e autodistruttivo che attraversa questo mondo, ma non c’è giudizio o commiserazione pietosa per questa umanità solidale che, in una sorta di ritrovata innocenza, accetta tutti senza giudicare. Cafè Lehmitz colpì subito per l’autenticità e la spontaneità delle immagini che, in un bianco e nero sporco e sgranato, dimostravano la sensibilità e il rispetto di Petersen che, come in un album di famiglia, rivelava la dignità di persone che, malgrado tutto, si mostravano vitali e non rassegnate. Non a caso Tom Waits chiese di utilizzare una foto, come copertina del suo disco Rain Dogs del 1985, e di incontrare Petersen che commentò: «Siamo stati bene insieme; parliamo lo stesso linguaggio». Cafè Lehmitz ebbe subito un grande successo, diventando riferimento seminale per la nuova fotografia di reportage che vive personalmente e intimamente le vicende che documenta (v. Nan Goldin. The ballad of sexual dependency , Il Fotografo n. 304). Prossimamente Schirmer/Mosel pubblicherà The complete Cafè Lehmitz Family Album con l’integrale dei 1.440 scatti, raccolti in 40 pagine di provini a contatto.
Di Vittorio Scanferla
Fotolibri da avere: Anders Petersen. Cafè Lehmitz
C'è 1 commento
Lascia un commento
Articoli correlati
Instagram
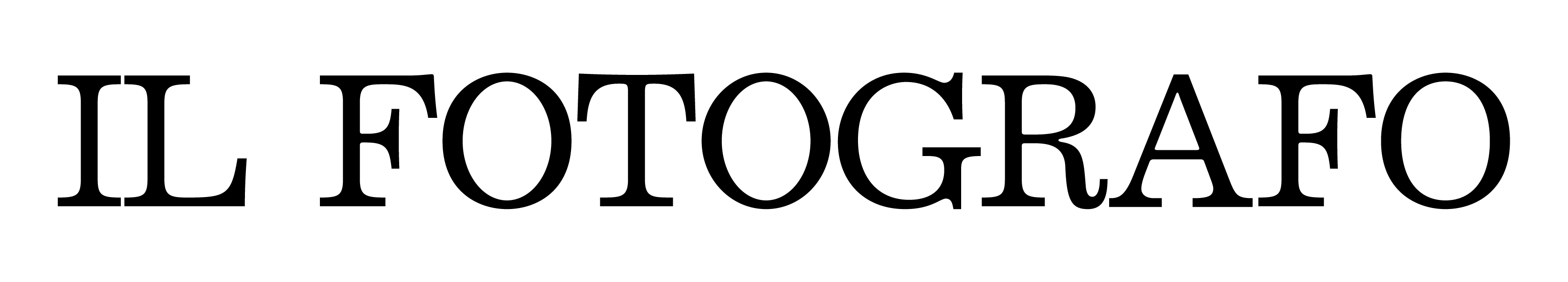
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI






[…] Le sue opere sono esposte in prestigiose gallerie di tutto il mondo, e i suoi libri fotografici sono ampiamente elogiati dalla critica, primo fra tutti il celebre Café Lehmitz. […]