Francesco Jodice
Per lui, ciò che dà valore all’opera d’arte è insito nella consapevolezza del progetto. Il suo interesse e impegno è che questa complessità progettuale sia condivisa con lo spettatore, non solo in termini di comprensione, ma anche di partecipazione. Il lettore, di fronte a una sua opera è chiamato a chiedersi che cosa sta guardando, decidendo – e questa è la su aspirazione – di aprire un dialogo e di avviare un percorso di scoperta. Rifugge la fotografia autoreferenziale, didascalica, quell’immagine il cui arco narrativo appare chiuso in se stesso. «Sono un fotografo, ma vivo nel mondo dell’arte – esordisce Francesco Jodice, a sottolineare la sua matrice ambivalente – Sembra una modalità un po’ ambigua, ma non potrei essere più a mio agio di così. La fotografia che appartiene al mondo dell’arte dev’essere fortemente radicata in una processualità e metodologia che ha una radice storica, lontanissima, che tutto sommato non è così diversa da quella dei grandi progetti realizzati per la Farm Security Administration, dove ancora era molto presente l’idea, e lo dico con apprezzamento, dell’indagine, della campagna investigativa, di una metodologia che porta a delle opere di grande respiro».
Intervista Francesco Jodice
Un progetto al quale lavori da anni è What we want . Me ne parli?
«Nasce nel 1996 – ha compiuto vent’anni – ed è di fatto il primo dei miei grandi progetti senza soluzione; nel senso che nel mio lavoro ho alcuni progetti seriali che non sono né site specific, né time specific. L’idea è che siano, paradossalmente, dei contenitori che aggiorno ogni cinque o sei anni dando loro la forma di un libro. Rappresentano delle lenti caleidoscopiche attraverso le quali è possibile osservare non solo il mutamento delle cose del mondo intorno a noi, ma anche il mutamento della cultura fotografica. Uso, dunque, anche lo strumento, il medium, come oggetto dell’indagine. Il progetto è nato dal desiderio di comporre attraverso la fotografia un grande affresco geopolitico di quello che sta cambiando intorno a noi e di capire come la fotografia, in quel momento fortemente in discussione come strumento capace di competere al pari del cinema, della televisione e del videogioco – ricordo che allora sembrava il lessico più precario fra quelli cosiddetti lens based – sia in grado di restituirci l’osservazione delle cose del mondo».
Questo universo, a oggi, che dimensione ha?
«Il progetto conta lavori realizzati in centocinquantatré metropoli nel mondo. Appare, quindi, come una sorta di archivio monumentale che continua a raccontarci le storie che stanno avvenendo attorno a noi. Il progetto si basa sull’idea che, viaggiando io in modo insensato – il mio lavoro mi porta ad avere un’attitudine rabdomantica, rizomatica – ogni cinque o sei anni raccolgo una parte significativa della ricerca, di solito quaranta o cinquanta opere, realizzate in altrettanti luoghi, e produco un volume, una mappatura, una mostra con l’idea di unire tutto il progetto in un unico grande archivio evento. Il vero senso di What we want è l’osservazione del paesaggio visto come la proiezione dei desideri della gente, cioè della capacità delle collettività, dei diversi consorzi umani, di proiettare sul territorio i propri desiderata. Naturalmente, nell’arco del tempo, il progetto ha subito le conseguenze dei grandi eventi storici. L’opera, mai in modo reportagistico, quindi diretto, ma in modo laterale, affronta i grandi temi della nostra storia. In questo lavoro c’è la caduta del Muro di Berlino, l’11 settembre, il fallimento della Lehman Brothers, lo scontro tra l’Occidente e l’Islam. Sono tutti presenti, ma mai in maniera frontale, come invece è il segno della cultura della fotografia reportagistica. È sempre un sistema, ma un po’ più sotterraneo».
Quale progetto personale stai producendo?
«Ho iniziato da alcuni anni a lavorare attorno al tema del fallimento del sistema economico culturale, civile e politico dell’Occidente, non visto come una specie di canto del cigno di quello che ha rappresentato il secolo breve, il secolo americano, ma piuttosto come mancanza degli occidentali a volersi confrontare con questo declino, evidenziando primariamente una sindrome da paura di prestazione. Il progetto inizia prendendo in considerazione un fatto storico, quando James Wilson Marshall nel 1848 trova la prima pepita d’oro in un fiume di una mesa californiana, e termina cinquant’anni dopo, quando il grafico delle azioni della Lehman Brothers esce dallo schermo e segna il crollo dell’era capitalistica. È questo, per me, il segno evidente di una fine, non l’11 settembre. Il lavoro di ricerca è totalmente sviluppato all’interno degli undici stati del Nord America nei quali avvenne la corsa all’oro»
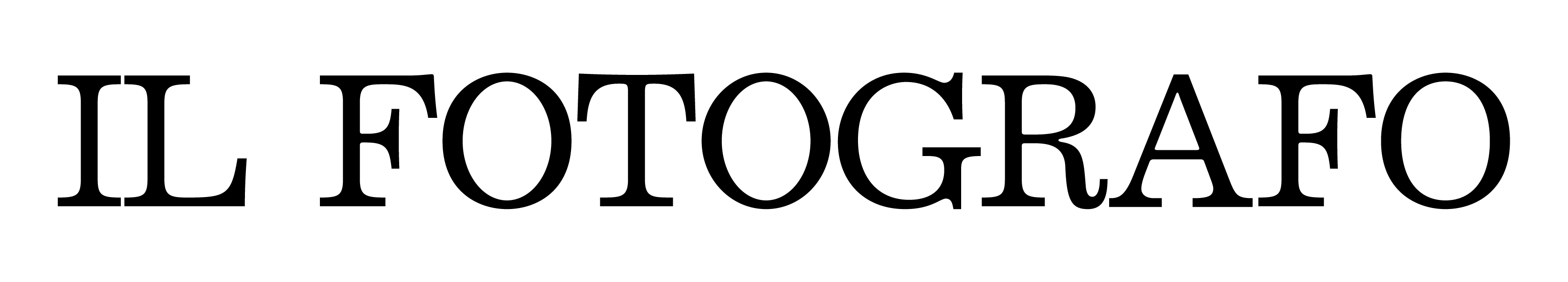
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





