Oltre 140 Polaroid negli ultimi trent’anni tracciano un percorso che abbraccia i ritratti e gli studi di figura, la moda e i suoi protagonisti, svelandone i segreti e i retroscena. Protagonista in assoluto, spesso animata da una ludica e irriverente ironia, c’è la donna. Non mitizzata, l’immagine rispecchia la profonda convinzione dell’autore milanese che il mistero legato all’universo femminile non debba mai essere completamente svelato. Pur aderente alla realtà, la fotografia di Barbieri diviene spettacolo, teatro, bellezza e metafora. Le seducenti istantanee risultano agli occhi del lettore oggetti di fascino, capaci di ricondurre a un immaginario ricco di magia, ma anche di ironia e di teatralità.
Intervista a Gian Paolo Barbieri
Come nasce il suo interesse per la fotografia?
Durante la scuola a Milano con due miei compagni e amici avevamo creato il club de I Vitellini e durante il fine settimana ci divertivamo a rifare varie pièce teatrali. Oltre al ruolo dell’attore, realizzavo i costumi – mio padre vendeva tessuti – e documentavo con la fotografia il nostro lavoro. Attratto così dal cinema e dal teatro volli andare poi a Roma. Avevo una camera in una pensione e mi pagavo il vitto aiutando in cucina. Per l’affitto, invece, facevo ritratti ai ragazzi di Cinecittà per i loro book. Sviluppata la pellicola, il proprietario della pensione mi permetteva di utilizzare il bagno di notte dove stampavo le mie foto e al mattino seguente le consegnavo dopo averle stese sotto il letto per farle asciugare. Un giorno, incontrai un conoscente di mio padre, Gustav Zumsteg, proprietario delle seterie Abraham di Zurigo, che mi chiese di fargli vedere i miei scatti. Li consideravo totalmente amatoriali, ma lui, dopo averli osservati attentamente, disse: “Hai una sensibilità pazzesca e sei tagliato per la moda”. Rimasi stupito, non sapendo nemmeno cosa fosse la moda. Mi consigliò di lasciare Roma e di rientrare a Milano. La vita nella capitale, in quel periodo, mi stava andando bene, ma sentivo che qualcosa sarebbe dovuto cambiare – e lui forse considerava quell’ambiente non adeguato a me –. Dopo qualche tempo ricevetti una sua lettera che m’invitava a presentarmi all’Hotel Windsor a Parigi per fare le collezioni di alta moda con Tom Kublin. Arrivai vestito di tutto punto, mi ricordo ancora. L’abito era un completo blu magnifico con dei bottoni di tartaruga – prendendo di nascosto la stoffa a mio padre potevo confezionarmi delle cose magnifiche –. Kublin era un grande fotografo che lavorava per Harper’s Bazaar . Mi osservò, mi chiese alcune cose e poi mi disse: “Da domani sei con me per due giorni, se funzioni resti altrimenti torni a casa. Ma soprattutto, non venire conciato così in studio”. Quest’esperienza di assistentato ha segnato l’inizio della mia carriera. Purtroppo sono stato con lui solo venti giorni – morì improvvisamente –, ma senza dubbio fu come fare un master, oltre a essere stati i più pesanti e faticosi della mia vita.
Cosa ritrova di Kublin nella sua fotografia? In altre parole, di quella breve e intensa esperienza formativa, cosa ha conservato?
«Mi ha insegnato molto. Cercavo in ogni modo di anticiparlo nelle mosse, ancora prima che riuscisse a esprimere il suo desiderio. Oltre al lavoro in studio, mi occupavo anche di consegnare gli abiti alle varie case di moda, da Dior a Givenchy. Durante la mattinata correvo poi per la città per far fare i vari test nei due laboratori colore e bianco e nero e per raccogliere i risultati. Il compito era di portarli a mezzogiorno a Kublin che, nel frattempo, si era svegliato e mi attendeva all’Hotel Windsor. Di lui, e quindi del suo lavoro, posso certamente riconoscere la grande puntigliosità e l’attenzione al dettaglio. Se trovava una piegolina nei fondali di carta eravamo destinati a rifarli pagando di tasca nostra. Era tostissimo. E mai sembrava completamente soddisfatto. Lavorava con una luce molto debole e ci poteva mettere anche delle ore per modularla sul corpo della modella che per nessun motivo poteva muoversi. Ne ho vista piangere più d’una. Una volta mi chiese di creare qualcosa che richiamasse Chagall al quale era ispirata la nuova collezione di Dior. Acquistai dei vasetti con vari pigmenti colorati e al mercato delle mimose e dei gladioli. Impiegai delle ore a preparare la scena. A un certo punto scese in studio, guardò, e mi disse: “Ma non ti avevo chiesto di fare così tanto”. Fu il mio riscatto».
Dopo Parigi, il ritorno a Milano.
«Scelsi Milano come base. Credo sia stata la scelta giusta fatta al momento giusto. Non ho più lasciato questa città, nemmeno quando mi chiamarono per andare a lavorare negli Stati Uniti. Alla fine, pur rimanendo in Italia, riuscii comunque a produrre immagini per Vogue America».
Guardando una sua fotografia, come la descriverebbe?
«Molto grafica. Molto precisa. E molto pulita. Non per nulla il mio maestro è Richard Avedon. Avrei voluto conoscerlo agli inizi della mia carriera quando andai a New York, ma purtroppo non mi ricevette. Poi, molti anni dopo, a Parigi, avemmo l’occasione di incontrarci e mi fece i complimenti per i miei lavori. Venni a sapere che aveva delle mie immagini appese nel suo studio».
Gian Paolo Barbieri
Polaroids and more
29 Arts in Progress Gallery
Via San Vittore 13, Milano
Fino al 27 luglio
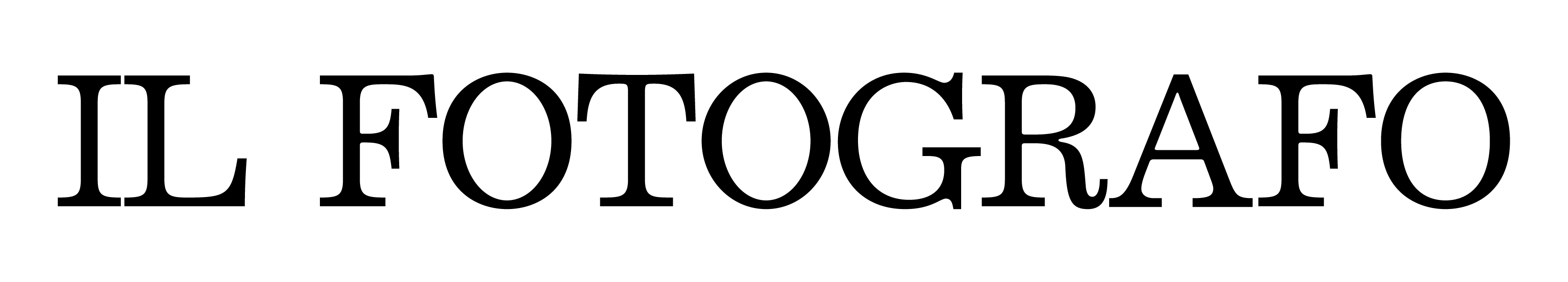
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





