Pacato, riflessivo, sempre curioso. Reza Khatir è un apolide, un uomo libero di mettere radici nel mondo. Iraniano, ha abitato a Tehran fino alla seconda metà degli anni Sessanta per poi vivere in Inghilterra, a Parigi e a Locarno, in Svizzera. Un passato da fotoreporter in Medio Oriente per poi decidere di lavorare su progetti personali, dove ricerca e passione, sentimento e visione, risultano gli strumenti del suo tool box comunicativo. L’elemento distintivo del suo fotografare, oggi, è la bellezza nell’imperfezione.
Ho iniziato il mio percorso professionale – dichiara l’autore – utilizzando la pellicola e, spesso, delle camere di grande formato come il Sinar 20×24. Ero interessato all’alta definizione e alla qualità. Ultimamente, la mia fascinazione verso la lomografia è dettata proprio dal contrario, cioè dall’utilizzo di prodotti assolutamente low-tech, con il fondamentale vantaggio che si possono avere degli ingrandimenti importanti senza perdere la qualità, perché la qualità non c’è a priori. L’unica clausola nascosta è che, vista la totale imprevedibilità e i limiti che un apparecchio con un tempo di esposizione unico e un diaframma approssimativo comportano, l’uso della lomografia richiede una certa competenza e pazienza. In fondo, questo mi permette di rivivere la magia di quella fotografia con la quale sono cresciuto.
Intervista a Reza Khatir
Cos’è per te la fotografia?
Per molti anni, quando pensavo a questo mezzo, mi veniva sempre in mente la frase di Edward Steichen quando diceva che serve a far conoscere un uomo a un altro uomo e l’uomo a se stesso. Oggi, per me, la fotografia è memoria. Tu comunichi qualcosa che hai già dentro. Te stesso, il tuo vissuto. Forse la natura ha inventato l’uomo per avere un testimone, qualcuno che documenti; solo che, purtroppo, uno dei nostri problemi è che non abbiamo più una memoria incontaminata, siamo talmente bombardati dalle immagini che non riusciamo più ad immaginare una cosa nostra. Questo inizia a mancarci. A questo serve la fotografia per me, a ricordarci chi siamo.
«Sono un immagazzinatore di situazioni senza la macchina fotografica. Non la porto mai con me. Raccolgo con gli occhi»

Le lune di Saturno, 2009
Diana 6×6 cm, Kodak Portra 160
Che senso ha realizzare degli scatti quando su Facebook sono presenti 250 miliardi di immagini?
C’è la febbre di condividere il caffè che hai appena bevuto. Abbiamo perso il senso di responsabilità nel produrre delle foto. Nella facilità di postare scatti realizzati ovunque, anche in luoghi privati, c’è un atteggiamento che faccio fatica a comprendere. Manca l’attenzione alla persona e soprattutto a chi hai vicino. Ci si rivede sui social dopo aver partecipato a una festa privata senza che nessuno ti abbia chiesto nulla. Inoltre, tutti scattano e nessuno produce più una stampa. A casa mia, sulla parete della cucina, ho le foto della famiglia. Il mio album è lì. Vedo i loro volti e loro sono sempre intorno a me. Questo è il mio patrimonio.
«Insegnare è molto gratificante, soprattutto quando riesci a trasmettere la tua esperienza»
“Nell’arco degli anni ho realizzato circa cinquecento fotografie con la Polaroid di massimo formato (50×60 cm). Quest’immagine è parte di una serie di trenta ritratti di richiedenti asilo ospitati in un ex-orfanatrofio in attesa della decisione delle autorità. Tra i lavori degli ultimi anni, rimane la mia preferita. È l’unico portfolio in Polaroid che ho conservato nella sua interezza. Nessuna foto è stata, né sarà mai venduta singolarmente”.
Cos’hai imparato lavorando in questi trent’anni?
Che tutto ha un ciclo. Ho realizzato dei lavori che in un determinato momento non creavano l’interesse desiderato. Vent’anni dopo sono stati riscoperti e apprezzati. Alle volte capita di essere in anticipo con i tempi. Ho imparato che bisogna sempre fare quello che ti riesce meglio, senza seguire le tendenze. E soprattutto, come ritrattista, ho imparato a rispettare le persone che fotografo e che si mettono a disposizione per aiutarmi a raggiungere il mio scopo. Pero, il mio scopo non potrà mai essere più importante della dignità della persona. In tutti questi anni non ho mai fatto firmare una liberatoria a nessuno, salvo per i lavori commerciali o pubblicitari. Se voglio fotografare qualcuno, famoso o no, non faccio mai uno scatto “rubato”, chiedo sempre e se la persona in questione non può dedicarmi un po’ del suo tempo per entrare in una comunicazione intensa con me, piuttosto rinuncio.
«Inizialmente, avrei voluto studiare cinema. È però un’arte collettiva. La fotografia è, invece, più vicina al mio essere. Io sono un solitario. Amo lavorare in autonomia»
“Appartiene a una serie di undici fotografie dedicate ai miei antenati. Sono immagini di inizio Novecento scattate da un mio avo e combinate con delle fotografie realizzate da me. In camera oscura ho creato dei montaggi. Ogni immagine è un originale unico, risultato di tre o quattro negativi sovrapposti. Ho voluto cancellare i volti delle figure per rendere l’atmosfera ancora più fantasmatica e misteriosa”.
Di Giovanni Pelloso
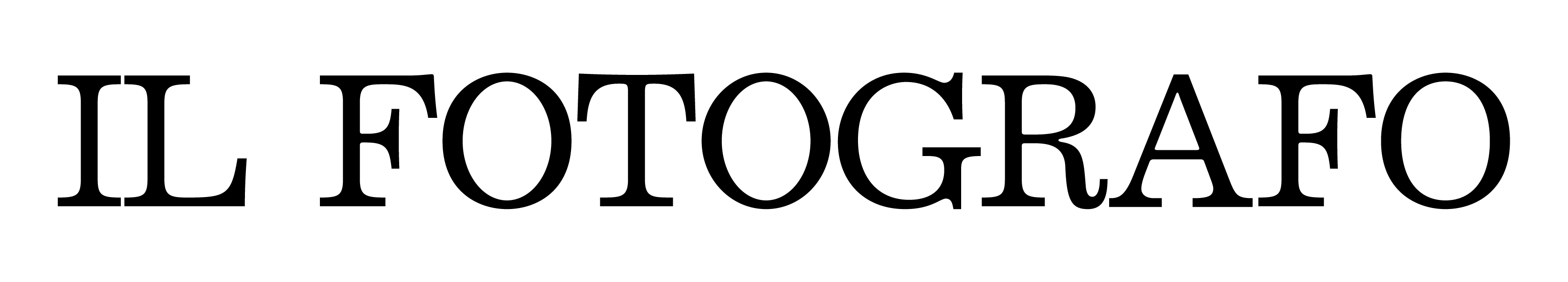
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI








