Al manicomio di Volterra
Ne avevo sentito parlare spesso, da fotografi e non. Un po’ perché da ragazzino entravo nell’ ex manicomio di Castelpulci, vicino a Scandicci… avevamo circa dodici, tredici anni, arrivavamo con la bici e la nascondevamo fra i cespugli temendo che i contadini lì intorno si insospettissero chissà di cosa. Ci sembrava una cosa fuori dal mondo eppure c’erano entrati tutti là dentro; e così sarà fino a quando qualcuno non appiccherà il fuoco a dei grossi catasti di vecchie riviste e libri. L’edificio verrà messo in -migliore- sicurezza, e successivamente ristrutturato fino a diventare Scuola superiore della magistratura. Oggigiorno, quando passo davanti a quella meravigliosa struttura, fatico a credere che sia ancora la stessa casa, fatiscente e oscura in cui accedevo da un cunicolo sul retro, alto meno di un metro e pieno di ragni, per sbucare in un ex locale caldaie che avevamo catalogato così solo grazie all’ uso delle torce.
Insomma, da quei tempi gli edifici abbandonati mi sono rimasti nel cuore: dalla polveriera Nobel a Poggio a Caiano, anch’essa con una gran storia alle spalle di cui magari un giorno vi parlerò, passando per il sanatorio Banti vicino a Monte Morello e la Fonte Roveta, che produceva bibite sempre sulle colline scandiccesi… i grandi classici delle rovine fiorentine posso dire di essermeli visti più o meno tutti. Ma c’era questo Manicomio di Volterra a farmi da tarlo nella testa.
Indiscutibilmente lontano, si fa per dire in un ambiente dove tanta gente è andata per passione fino in Islanda, ma sicuramente lo è rispetto ai cumuli di relativamente ben messe macerie fiorentine, il sopraccitato è uno di quei posti di cui ti sono per forza arrivate delle voci almeno una volta nella vita: “se ti piacciono gli edifici abbandonati VAI al manicomio di Volterra” oppure “ci sono stato una volta a far foto ma non so se sia ancora aperto”. Passando per “è infestato” (giuro). Vicino a organizzarmi con amici un paio di volte, la “spedizione” è finalmente decollata quando lo scorso autunno mi ero preso una piccola pausa dalla fotografia naturalistica, dedicandomi a delle cascate nelle montagne del pistoiese con l’amico Simone, qualche foto di paesaggio con i filtri, degli HDR, e due concerti Heavy Metal, quest’ ultimo un genere al quale mi sono dedicato solo in tempi molto recenti. E’ dunque capitata nel momento giustissimo, non giusto, la visita semi-guidata che ho trovato grazie ai social network sulla pagina “I luoghi dell’ abbandono” (che ringrazio anticipatamente per aver reso possibile tutto questo).
Pronti. Via. Avevamo già segnato tre nomi sull’ agenda degli organizzatori e personalmente detto al datore di lavoro che no, per Epifania non ci sarei stato (al pubblico purtroppo è così, ma finchè si può decidere ben venga quest’aspetto positivo della faccenda), e l’attesa si faceva crescente settimana dopo settimana. Uno dei tre si è ammalato qualche giorno prima ed è stato un vero dispiacere per il sottoscritto, perché si trattava della persona che mi ha letteralmente insegnato buona parte di quello che ho imparato in questi primi sei anni di fotografia amatoriale, oltre ad avermici fatto appassionare, e perché già avevamo pianificato un giro alla Nobel senza poi andarci; l’altro, il mio migliore amico, per fortuna viene ma scambia “solo per fotografi” con una trekkingata della domenica iniziando a farfugliare last-minute di “posso portare anche…”, il che faceva sorgere domande sul perché dei nomi comunicati sulla lista. In risposta a tutto questo, soffrivo in silenzio.
All’ indomani ero già certo di cosa portarmi dietro: solo il Sigma 18-35mm f1.8 ART, il fratellone 50-100mm nello zaino pronto all’ occorrenza a giustificare il suo chilo e mezzo (avverrà soltanto alla fine, ma avverrà!), un treppiede leggero (Benro Travel Angel di cui non dispongo più) e la nuova testa a sfera, da inaugurare nel posto più lercio possibile, la SunwayFoto XB-44, acquisto che dopo pochi utilizzi posso confermare come azzeccatissimo.
Il viaggio è stato piacevole: sosta al bar con cornetto e cappuccino, chiacchiere con l’amico di sempre, disco dei Metallica in sottofondo e cielo sereno. Una volta nei pressi di Volterra, si passa praticamente per forza da quella collinetta dove c’è una bella vista panoramica sulla sinistra, in pessima illuminazione, e a bordo strada quell’ abusatissimo cerchio dentro al quale in tanti hanno incorniciato le sottostanti colline: “fermiamoci”! Il tempo di aprire lo zaino della Lowepro, che penso sia uno degli oggetti più longevi che ho acquistato in materia di foto, e la sola parola che ricorre è: FREDDO. C’erano sei gradi sotto zero, sole sì o perlomeno stava arrivando, ma un vento pazzesco che aumentava quella percezione di disagio e tramutava la voglia di andare a fotografare un posto pazzesco e pieno di significati in divano-film-2caniincollo.
Il tempo di constatare che quella foto era troppo brutta per scattarla, ed ero di nuovo in auto, con i Metallica di San Francisco ed il mio amico di Scandicci. Volterra era vicinissima, qualche rara pozza ghiacciata nei campi resisteva dove il vento aveva colpito di meno, e avevo di nuovo fame. L’idea -poi bocciata- di comprare il giorno prima una quantità disumana di Ritter Sport e divorarli in loco già la rimpiangevo, ma soprattutto non sapevo perché avevo deciso che “mi arrangerò sul posto!”, se stavo andando in un edificio abbandonato da decenni? Ecco la città, ed ecco una collina adiacente, molto più ombrosa per la boscaglia presente. Ovviamente, non era sulla collina soleggiata che stavamo andando. C’è un parcheggio, ampio ma non lo sarà abbastanza dopo qualche ora, è praticamente vuoto per la sua mole ma a giudicare dalle persone in piedi vicino ad un gazebo, sembra di essere arrivati all’ EXPO della fotografia. Edizione 2017, Volterra. Cavalletti, conteggio delle Nikon e se sono più delle Canon, “sì lo sono!”, gente accompagnata da fidanzate, io che avevo detto al mio amico che era una roba solo per fotografi, un cane al guinzaglio. Freddo.
Si chiacchiera, si fa l’iscrizione al gazebo compilando un modulo che è una sorta di scarico della responsabilità, ovvio per il posto in cui si entrerà, e poi ci si incammina su. Compilare quel modulo è stata una roba impossibile, le mani non funzionavano e la calligrafia sembrava quella del dottore che mi prescrive il Fluimucil tutti i dannati inverni. Siamo fra i venti e i trenta, e sarebbe un numero giusto considerando che ci si sparpaglierà per vari edifici. Diventerà un numero sbagliato ma scopriremo più avanti il perché. La salita è tutta all’ ombra, maledico l’estate passata in cui ho perso la mano col trekking e finalmente arriviamo a quello che una volta era la perfetta via di mezzo fra un ospedale, un carcere, ed un Inferno. C’è questo viottolo che costeggia quelli che erano stati giardini curati, ogni struttura ne aveva uno e il tempo all’ aria aperta faceva parte della riabilitazione, quando il meteo lo permetteva. La parte guidata narra a grandi linee la storia del posto soffermandosi tanto su un paziente che occupò la struttura denominata “Ferri”. Ci troviamo accanto a questo muro, all’ esterno, completamente inciso da una persona con un metodo di scrittura non convenzionale per i nostri tempi e contenuti solo a tratti comprensibili. Dentro, il vento faceva sbattere forte qualche finestra spalancata. Era il perfetto preludio.
Il bello, o il brutto, è che quando parti per un’ uscita fotografica e ti ritrovi a vedere una cosa del genere ti inizi a immedesimare. Non nel pazzo s’intende, ma nella situazione: negli stanzoni dove un guardiano faceva camminare in cerchio i degenti fino a che per sfinimento non andavano a dormire, in quel “Ferri” che altro non era che la struttura che accoglieva solo ed esclusivamente coloro che avevano precedenti penali, e in quelle persistenti scritte sul muro con taglio mai stondato che tanti occhi dovevano aver visto e chissà se con indifferenza o no. Le scritte erano di Oreste Fernando Nannetti, detto N.O.F.4, un romano che il trasferimento a Volterra l’aveva preso con il silenzio assoluto a cui erano seguite, appunto, le incisioni sul muro. E che nell’ illusione di tornare a casa per l’amore verso la sua città, morirà proprio a Volterra.
Coinvolti o no dalla storia del romano, la gente stava congelando e la ragazza di un fotografo letteralmente tremava. Un paio di tizie sfidavano i meno sei sotto zero con la caviglia scoperta, pronte a riaprire la struttura ed essere internate magari lì al Ferri, e la guida decise di lasciarci liberi un po’ prima del previsto. “Tutti dentro al Ferri come cavallette impazzite che devono devastare il campo più vicino”. Io e il mio amico Daniele, scappiamo in direzione opposta e ci fiondiamo dentro l’edificio meno accessibile dalla strada, quello con il viottolo più nascosto dalla vegetazione e un muricciolo da saltare, che alle mie ginocchia da appena 34enne causano uno scompenso (niente pubblicità dell’ Olio Cuore, no!). Nulla di paragonabile al buio cunicolo di Castelpulci, ma eravamo nuovamente gasati come allora. E infatti, la prima ora è stata bellissima. La migliore.
Eravamo soli in un edificio che capiremo più avanti avrà una struttura diversa ma simile a quella di tutti gli altri: ognuno ha la sua mappatura, ma tutti quanti sono tirati su secondo una simmetria che ha del disumano. Sono progettati meticolosamente, e il fatto che stiano ancora decentemente in piedi significa che erano anche ben costruiti. Sempre in tema di simmetria, se c’è uno stanzone all’ estremità di sinistra, quasi sicuramente ce ne sarà uno identico dalla parte opposta dello stabile, con le stesse finestre imponenti e alte più di due metri, corredate da solide inferriate. Quella nella fattispecie era una casa di terapia: li mettevano fuori in carrozzina rivolti verso la direzione del mare, convinti che l’aria del Tirreno li avrebbe fatti stare meglio. Poi capirono che non serviva assolutamente a nulla. L’umidità dentro c’era ma la percepivi soltanto in piccole e buie porzioni di palazzo, per il resto valeva la solita regola dell’ esterno: un gran vento freddo. E pensare che un tipo aveva rassicurato la sua metà con un “dai, tra poco si va dentro”. Dove è ancora più buio. C’era qualche parte del soffitto pericolante, per non dire pronta a staccarsi. Il perchè del foglio compilato, giustamente. Daniele mi ricordava “guarda sempre in alto prima di entrare in una nuova stanza”. Alla quarta ammonizione, iniziavo a farlo davvero, perché inizialmente me ne dimenticavo sempre per l’euforia. Fuori le macchine fotografiche! Lui non trovava la misurazione in spot sulla D90, io non trovavo le mani per trovargliela. Poi è stata almeno inizialmente, un’ esperienza tutta in discesa: prime prove col cavalletto, un light painting improvvisato con la torcia del cellulare e una mini-torcia vera e propria, un HDR che si rivelerà essere mostruosamente brutto per non cancellarlo, passi all’ esterno in avvicinamento ed ecco i primi due visitatori che ci raggiungono. Va benissimo così, e alla fine ci rechiamo al secondo edificio, perché il primo l’ avevamo rastrellato come se ci avessimo perso il portafogli o le chiavi della macchina…
La Sunway XB-44 si rivela essere una gran testa a sfera, per essere alla prima uscita. Anche se non ne sto scrivendo la recensione, ho fatto per cinque-sei anni giornalismo musicale e le abitudini sono dure da perdere. Dichiara un carico di oltre 40 kg, l’ho presa per sostituire letteralmente le tre teste che utilizzavo in precedenza con una sola che mi soddisfi più o meno in tutte le situazioni. In attesa di provarla in macro, dove sicuramente sarà meno indicata dell’ accoppiata Manfrottone 055 XProB – Junior 410 a cremagliera (ottima, ma spostatevici per un chilometro nel bosco… vi sfido!), ma ha una solidità metallica (non di San Francisco) e un peso contenuto, oltre all’ ingombro minimo, entrambe caratteristiche da urlo. Il problema è che regolare la minuscola frizione con le mani gelate era come fare quel chilometro nel bosco con l’accoppiata di cui sopra! Il Benro Travel Angel invece -lo sostituirò più avanti con un leggero ma stabilissimo Feisol senza colonna centrale, rivendendo in coppia anche il Manfrottone- si conferma una piuma, ma non lo sfiorare o va giù ogni cosa. E la D500 non deve andare giù! Eppure c’erano sopra 900 grammi scarsi di corpo macchina, e il 18-35mm che alcuni accusano di pesantezza, ma a me sembra perfetto per una reflex del genere. Insomma, niente di così eccessivo.
C’è questa Street Art un po’ dappertutto. Inizialmente mi da’ fastidio, poi trovo che abbiano fatto un lavoro di caratterizzazione incredibile, riuscendo in alcuni casi quasi a farti credere che certe cose le abbiano fatte i “pazzi” all’ epoca. A giudicare dalla pessima conservazione di alcuni dei dipinti o murales, direi che hanno iniziato a comparire poco dopo la chiusura dello stabilimento, che risale a fine anni ’70 inizio anni ’80. Mi colpisce uno scorcio dove a sinistra c’è una stanza illuminata con dei tulipani rossi dipinti sul muro. L’infisso a dividere la scena, e a destra un corridoio buio, con la luce che proviene da una porta in fondo. In mezzo al corridoio, tante porte spalancate, quasi come se li avessero liberati tutti insieme.
L’edificio successivo è su più piani come tutti gli altri, la differenza è che i piani superiori non sono accessibili per il pericolo, in alcuni casi gli accessi sono proprio murati o limitati da blocchi. In questo nuovo edificio, lo Charcot, è presente però un piano inferiore con delle luci semplicemente fantastiche.
Chiaroscuri dappertutto, tanta possibilità di fare low-key come personalmente adoro e come penso sia impossibile non farne in un posto del genere, il Sigma 18-35mm che rimane incollato alla Nikon D500 in mezzo a questo stanzone pieno di colonne, luci che filtrano, e finalmente colori. Tanto blu vivo, e accanto un’ altra stanza, piccola e piena di cisterne appena illuminate. Fuori il vento continuava a sbattere le fronde degli alberi, ma si iniziava a stare meglio. Erano i Ritter Sport a mancarmi di più, ve lo posso mettere per iscritto. Più di ogni treppiede, flash, trigger o pannellino che inizialmente potevo aver avuto la necessità di tenere lì con me, e che a quel punto davvero erano superflui pezzi di plastica e altri materiali che andava benissimo fossero altrove. C’erano i panini, ma erano in auto (“si mangia al ritorno”) e chissà a quale temperatura era arrivato il prosciutto crudo.
Si esce e si va al Ferri, in tutto abbiamo incontrato una decina di persone ed ogni cosa, tranne una leggera sensazione di stanchezza e quella maledetta fame, è andata per il verso giusto.
Il “Ferri” è bellissimo, superiore di almeno una spanna (almeno qua non conto in stop!) al secondo edificio, e leggermente superiore al primo. E’ un po’ come un ufficio postale al buio con tanta gente che cerca i bollettini da compilare, e non li trova. Un modenese va su tutte le furie perché durante una lunga esposizione gli passiamo tutti davanti (il tipo non era neanche minuto ma non si vedeva), inizio a essere davvero stanco per la levataccia e il lavoro del giorno prima ma infilo dentro a una serie di stanze troppo evocative per non dedicarmici. Il treppiede per ora non lo considero più, la Toscana è tutta lì dentro: i gruppi erano di 20 o 30 persone, ma erano al plurale. Si susseguivano a una distanza di un’ora credo, ma a un certo punto della mattinata eravamo davvero tanti la’ dentro.
Trovata una zona di passaggio stranamente non troppo frequentata, abbiamo iniziato a dare di matto col cavalletto (finalmente!) usando tempi relativamente brevi ed il nostro mosso, in ombra, scurendo successivamente i soggetti con scherma/brucia di CC in seguito ad una gradita conversione in B/N. Il risultato non è quello sperato ma neanche troppo insoddisfacente. Diciamo che, per essere una delle 2-3 foto che avevo pianificato di scattare, poteva e doveva venirmi meglio. Il problema è che per fare comparire la figura (del mio amico) come volevo, ci abbiamo impiegato una ventina, forse anche trentina, di tentativi. E incredibilmente, in quel lasso di tempo non è passato quasi nessuno di lì!
Comunque sia, si era rotto l’idillio. Era completamente scomparsa quella sensazione di degrado, oppressione, solitudine che un luogo del genere può trasmetterti. C’erano i selfie, le merende (io no!), quelli che smattavano (nel manicomio di Volterra) perché non riuscivano a posizionare il treppiede al centro di stretti corridoi senza che la gente ci passasse lo stesso. Fu allora che decidemmo di andare via.
Al ritorno la prima cosa che abbiamo fatto è stata raggiungere il gazebo, e chiedere informazioni sul cimitero e sul museo. Volevamo vederli entrambi. Per il primo, c’era una distanza di qualche chilometro da percorrere in auto, il secondo era davvero vicino al parcheggio (ora simile a quello dell’ Ipercoop il giorno prima di Natale, con il Ferrari a sconto del 50%). Una sosta alla macchina, appoggiamo un momento l’ attrezzatura e prendiamo quei dannati panini. L’alluminio che li avvolge è gelido, non li apro nemmeno. Di nuovo al gazebo, dove ci nominano la parola “MENSA”. Poco più su, un bar con uno stanzone pieno di tavoli, ribollita e paste al salmone, carne, pesce fritto. Inizio a mescolare ogni cosa, chiudo con un caffè, dimentico che la grappa sarebbe stata la perfezione a quel punto della giornata e siamo pronti per il museo. E non ci crederete, ma sarà un’ esperienza bellissima.
Il museo è piccolo e semplice, costruito in una struttura che anticamente era il luogo dove i degenti arrivavano, venivano osservati, spogliati di tutti gli oggetti per una completa spersonalizzazione, vestiti in maniera anonima e infine collocati nell’ edificio ritenuto il più appropriato. E spesso non lo era per niente. Ci finivano infatti coloro che erano accusati di “pubblico scandalo”, il che in periodo fascista derivò un’ impennata incredibile nel numero di internati (se non erro fra i 3500 ed i 4000 nel periodo di massima espansione), ci finiva gente che parlava il sardo perché secondo qualcuno era una patologia (!!!), e poi chi aveva commesso piccoli crimini oltre, ovviamente, a ritardati, schizofrenici e tant’altro. Doveva essere una gran confusione. Lì dentro c’è una sala interamente dedicata a N.O.F.4, un’ infinità di libri perfino con ritratti dell’ epoca che mettono davvero i brividi, vestiario originale, oggetti comuni (scodelle e cucchiai, per esempio)… poi c’è questo macchinario assurdo: vetro tutto attorno, una marea di lampadine e la struttura portante in legno. Tu venivi chiuso lì dentro con la testa fuori, irrorato da una fortissima luce cosicchè la temperatura corporea si innalzasse, anche col favore dello specchio posto alla base. Poi venivi tirato fuori e gettato nell’ acqua gelida, perché per loro per diventare pazzo avevi subito uno shock fortissimo, e per tornare indietro dovevi subirne uno ancora più forte.
Volterra intesa come manicomio diventò un business vero e proprio. Partì con un convento che ospitava pochissimi infermi (tre) perché le province dovettero improvvisamente occuparsi dei propri. Pisa, che li spediva a Firenze (San Salvi) o a Siena, li mise lì. Poi le tasse sul pane e sul sale, che Volterra non pagava, resero meno costosa la collocazione dei degenti all’ interno del proprio territorio. Volterra iniziò a chiamarli da fuori, dalla Sardegna per esempio, ma anche da Roma come nel caso di N.O.F.4. Ed ecco che è nata la cittadella (nel museo tramite una fotografia panoramica che cavalca le decadi si osserva benissimo la sua evoluzione), col Ferri e con tutti gli altri padiglioni. Erano veramente tanti, alcuni neanche si vedono perché sono appena dietro la collina ripresa nelle immagini. L’edificio in cui ci troviamo, al cospetto di molti altri, è un ripostiglio.
Non ci resta che il cimitero, da cui siamo divisi da una serie di tornanti che ti fanno pensare di esserti perso e di dover tornare a chiedere all’ organizzazione (che ce l’aveva detto, “vi sembrerà di esservi persi a quei tornanti, ma andate ancora avanti!”). E’ anonimo, ci sono una valanga di lapidi minuscole e tutte uguali, bianche, sovrastate da alcune che sono più personali, segno che molto probabilmente i parenti avevano sborsato soldi per loro. In proporzione, quelle a “croce” o a “lapide”, sono molte meno di quelle minuscole e bianche. Pochi visitatori l’hanno raggiunto, ma a mio avviso è un’ altra parte fondamentale. Perché molti ne uscivano, molti altri ci morivano, e lo facevano in pieno dimenticatoio.
Ce n’è una a forma di croce che è letteralmente storta, compie un angolo fra i 40 e i 50 gradi. Aspettiamo 20 minuti che la luce ci passi sopra e la fotografiamo: è tardo pomeriggio ed è ora di ripartire per Firenze. Al ritorno un’ unica sosta, vicino a Castel San Gimignano per fotografare col 50-100mm (utilizzato finora solo al cimitero) un albero solo in mezzo a un vigneto. I colori sono rossissimi, e tutto si conclude lì. Le trattative per la cessione del Manicomio di Volterra potrebbero renderlo inaccessibile anche mediante visite guidate nell’ immediato futuro, quindi, se vi capita l’opportunità, coglietela al volo perché è un’ esperienza che reputo imperdibile.
Marco
Nikon D500
Sigma 18-35mm f1.8 ART
Sigma 50-100 f1.8 ART
Volterra, PI, Italia
2017/01/06
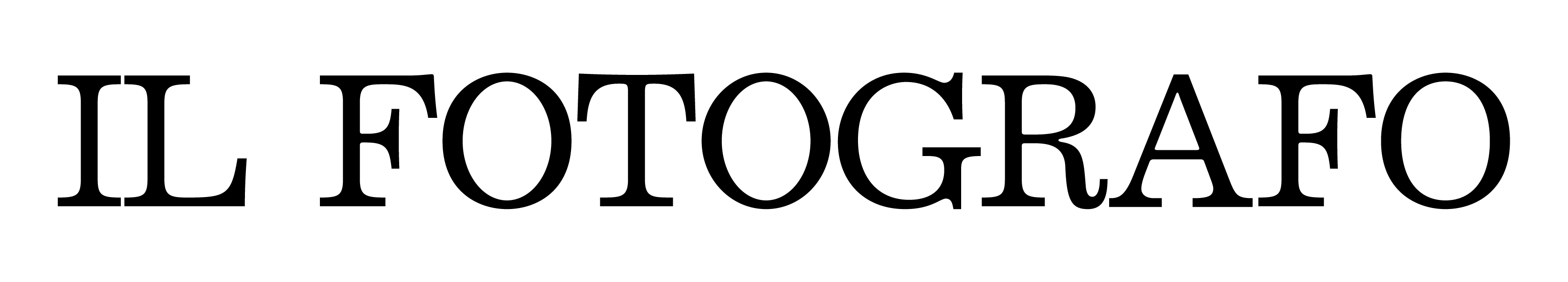
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI




