Vincitore dei Sony World Photography Awards 2018, categoria professionale “Architecture”, con il progetto Buildings, da diversi anni Gianmaria Gava porta avanti una ricerca molto interessante sulle potenzialità del mezzo fotografico: strumento capace non solo di documentare ciò che ci circonda ma anche di manipolarlo. Le sue immagini sospendono lo spettatore tra reale e irreale, mettendolo di fronte a una scelta radicale.
Intervista a Gianmaria Gava
Gianmaria, come ti sei avvicinato alla fotografia e cosa rappresenta per te?
Ho iniziato a occuparmi di fotografia ai tempi dell’università, quando studiavo Scienze Politiche; ho seguito un corso di fotografia all’Università di Trieste e mi sono subito appassionato. Credo che all’inizio, come capita a tanti fotografi, a interessarmi sia stata l’immediatezza del mezzo e soprattutto la capacità di registrazione del reale. In verità, poi, tutto il mio percorso fino adesso è stato praticamente opposto: sono partito dalla capacità della fotografia di rappresentare il reale e sono andato sempre più verso il surreale e quindi verso la possibilità di astrarre la realtà, di modificarla e manipolarla. È interessantissima nella fotografia questa doppia potenzialità: può sia rappresentare ciò che ci circonda sia camuffarlo, modificarlo e renderlo completamente diverso.
Questa doppia potenzialità si lega al tuo progetto Buildings: ci racconti come è nato e qual è il senso di questo lavoro?
Ho iniziato a occuparmi di architettura nel 2015 ma in studio: ho creato piccole sculture con forme geometriche di base, i classici blocchi di legno utilizzati dai bambini, che rappresentavano archetipi del costruire, e le ho fotografate. Mi interessava il rapporto tra architettura e geometria. Poi, nel 2017, ho iniziato a portare questa esperienza dallo studio alla strada. Ho fotografato diversi tipi di edifici e ho cercato di rendere il più chiara possibile la relazione tra l’architettura e la geometria. Per arrivare a questo ho fatto un lunghissimo processo di modifica digitale dell’immagine, togliendo le informazioni visive e la maggior parte degli elementi strutturali (porte, finestre). Ho quindi pulito le facciate degli edifici evidenziando la struttura geometrica di base, rendendoli semplici solidi di base. Questo è stato il mio primo intento. Successivamente, mi sono reso conto che la seconda conseguenza – che forse per me è diventata la più importante – sta nella reazione dello spettatore di fronte alle immagini. La maggior parte degli spettatori crede di trovarsi di fronte a qualcosa di reale, per altri si tratta di edifici irreali. Tutto il lavoro è basato sulla percezione, sulla linea sottile che divide reale e irreale, sul probabile: gli edifici sono reali, occupano una porzione di suolo, esistono nella realtà ma esistono in modo molto diverso da come appaiono nelle mie fotografie.
Quali elementi valuti per capire se un edificio entrerà a far parte del tuo progetto?
È sempre un percorso lungo che richiede moltissimo tempo e altrettanta ricerca. Fondamentalmente è un lavoro che si basa sul fatto di camminare per la città e cercare gli edifici adatti, dedicando moltissime ore per molti giorni. È un lavoro in negativo, di scarto, piuttosto che di ricerca di un edificio particolarmente interessante. Considerando 1.000 edifici, 999 non saranno fotografati e ne rimarrà uno su tutti. Ci sono molte difficoltà. Una è la struttura dell’edificio stesso, la superficie: una post-produzione di questo tipo si può fare in modo perfetto solo con il cemento. Quindi c’è un elemento architettonico di base e poi ci sono altri elementi: in tutte le immagini della serie non ci sono persone, automobili o altri tipi di veicoli (ci troviamo in uno scenario post-umano). E in una città trovare queste condizioni è praticamente impossibile. Se davanti alle finestre o alle porte ci fossero alberi, pali della luce, fili elettrici, questi edifici verrebbero scartati. Perché il lavoro è basato su una pulizia estrema. Anche il cielo, giusto per rendermi la vita più difficile, è sempre lo stesso: è un cielo invernale, latteo, quasi bianco che mi ha permesso poi di avere ombre ridottissime e di avere un approccio estremamente oggettivo, simile allo stile della Scuola di Düsseldorf, che per me è fondamentale come riferimento.
Hai detto che le tue immagini non possono essere consumate in fretta: che valore assume tutto questo in un’epoca in cui siamo saturi di immagini che passano senza lasciare il segno?
Ci vorrebbe un’altra vita come diceva Paolo Conte. Io sono un iper critico della velocità, del consumo di immagini, però sto cercando di aprirmi a questo. Fino a poco tempo fa non avevo nemmeno un account Instagram, ora ce l’ho e cerco di usarlo in modo intelligente. Ogni giorno vengono prodotti e messi in Rete due miliardi di immagini, ci troviamo di fronte a un’enorme rivoluzione che ci sta cambiando. È interessante notare come alle mie mostre molte persone credono davvero che esistano edifici senza porte e finestre. Assurdo, a ben pensarci. Nessun costruttore sano di mente butterebbe via i soldi per dei bunker. Significa che siamo completamente immersi nel digitale. Tanto da non capire più i limiti, che cosa è reale e che cosa non lo è.
L’intervista completa la trovate su Digital Camera Magazine n. 200
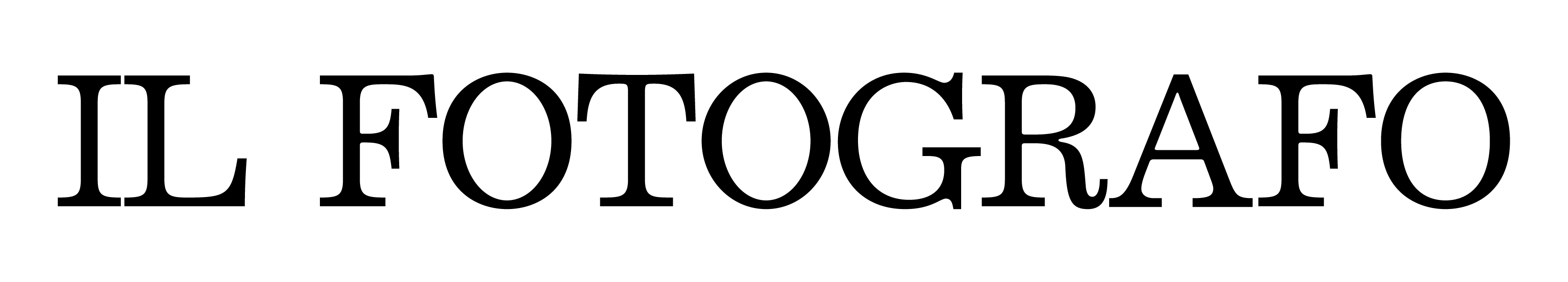
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





