Beat Kuert
Il desiderio del corpo e l’aspirazione poetica nell’opera di un artista che usa la fotografia per esplorare l’inconscio.
Nell’ammasso confuso di immagini che definiscono la nostra contemporaneità è difficile che una di queste riesca a scalfire la corazza della retina; di solito l’overdose dei bulbi oculari produce oblio e l’abbuffata visiva, al massimo una cattiva lacrimazione. Eppure, alcuni artisti riescono nel miracolo di immaginare fuori da questo fluire incessante, una sorta di sottofondo rumoroso che impedisce ogni nuova visione nell’epoca del non plus ultra. È il caso di Beat Kuert, alle spalle una brillante carriera come regista e tante incursioni nel mondo della video arte, il cui lavoro si svolge su diversi piani concettuali e performativi e solo alla fine, dopo un lungo lavorio, si traduce in fotografie di rara potenza evocativa come nell’ultima serie dedicata al corpo, Furor corporis, il furore del corpo, ma anche, stando all’etimo, il desiderio del corpo, l’aspirazione poetica, la passione violenta, che si sublima in una folgorante catabasi, quasi onirica, nel profondo del nostro essere, dove la nudità e il movimento si intrecciano in modo ancestrale. Le immagini di Beat Kuert, di cui riconosciamo i pregi dell’espressionismo tedesco e la forza tellurica dell’azionismo viennese – due mondi vicini all’artista zurighese per lingua e Heimat –, sono infatti frutto di stratificazioni,
di manipolazioni formali e temporali.
Beat Kuert: immagini sorprendenti, graffiate, sovraesposte
Immagini sorprendenti sul punto di sgretolarsi, graffiate, sovraesposte, in cui più piani si intrecciano a formarne uno ulteriore che non esiste
se non nell’occhio dell’artista. Immagini che nella loro risultanza estetica, tra bianco/nero e colore, superfici specchianti e ruvide, dimensioni grandi e piccole, colpiscono lo spettatore
e lo costringono a una profonda riflessione su cosa sia il corpo, cosa sia lo spazio che lo contiene, cosa sia il tempo che lo annienta. E non importa che la sorgente sia una performance, poiché Beat Kuert agli albori è stato un performer, ma a differenza di questi, l’opera non si risolve e non finisce nel tempo puntuale della messa in scena, piuttosto trova compimento in studio, con un lungo e ossessivo lavoro di post produzione, quando l’artista non è limitato dall’elasticità o dalla resistenza dei corpi degli attori utilizzati, e può spaziare in tutti i versi, libero da ogni costrizione, dando sfogo alla creatività più assoluta, a un subconscio dove si mischiano incubi e visioni, bellezza e orridi, difformità e compostezza lirica. Le immagini, frutto inizialmente di una performance, elaborate quasi al limite dello sfinimento si moltiplicano dunque all’infinito. Spesso i simboli sono ripetuti, i segni si riproducono: lo stesso volto, la stessa donna, la stessa situazione ricompare più volte, mentre le correlazioni consuete, a cui siamo abituati, sembrano venir meno. Il nesso causale tra un’immagine e l’altra si perde in quello casuale, quasi che l’artista prediligesse il semplice accostamento o l’evocazione insensata, e invece in una dimensione estetica esplosiva tutto risponde comunque a un intreccio profondo, a quella “sincronicità” evocata da Jung nella sua dimensione psicologica e approfondita in modo più razionale dalla meccanica quantistica. Risponde cioè al fatto che nell’universo ci sono cose legate da sempre, intrecciate fin dall’inizio, e che restano legate anche se lontane nel tempo e nello spazio, anche se noi non ne possiamo cogliere i nessi.
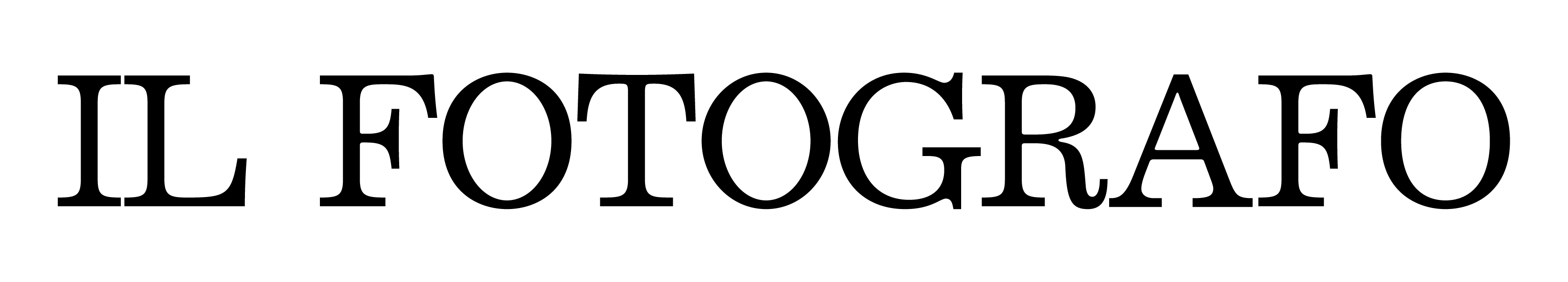
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





