Arca Russa: l’Europa dell’Est vista da Calogero Russo
di Giovanni Pelloso
Come è cambiata l’Europa dell’Est dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine di quella Guerra fredda che per decenni ha tenuto il Vecchio Continente in uno stato perenne di tensione? E qual è il retaggio lasciato dal regime sovietico a Berlino e nei Paesi dell’ex blocco guidato da Mosca? Sono queste le domande che animano gli ultimi progetti di Calogero Russo, fotografo che ama dedicarsi a reportage a medio-lungo termine.
Intervista a Calogero Russo
Calogero, raccontami come nasce il progetto Arca Russa.
L’idea è partita da una mia curiosità e dalla voglia di conoscere quello che è oggi l’Est Europa, ossia quella parte di mondo che è stata sotto l’influenza politica dell’Unione Sovietica. È un lavoro che ho sviluppato lentamente nell’arco di dieci anni. Ho visitato prima l’ex DDR e tutta la parte dell’ex Jugoslavia per poi addentrarmi fino alla Moldavia, alla Lituania, all’Estonia e alla Lettonia. Infine, in Russia ho vissuto e lavorato per quasi un anno. Ero a Berlino quando mi sono reso conto che potevo rintracciare in questi luoghi quella cultura identitaria riferita a un passato regime che a Mosca non percepivo più. Mi riferisco a quel senso di appartenenza al mondo e all’ideologia comunista di cui la “madre patria” si è rapidamente liberata alla fine degli anni Ottanta. Nella capitale tedesca, invece, avvertivo il desiderio di non tradire il proprio passato. Semmai, di sfruttarlo. Nelle strade, per esempio, potevi incontrare vecchie Trabant ristrutturate per il turista che può affittarle e sperimentare un particolare lifestyle.
Il progetto, quindi, nasce inizialmente a Berlino?
Sì, era il 2014. Con Ostalgie volevo raccontare gli anni successivi alla caduta del Muro. Il mio desiderio era di misurare, attraverso l’indagine fotografica, quanto del vecchio regime fosse ancora presente nella vita di tutti i giorni. Poi, recandomi in altri Paesi dell’ex blocco sovietico e guardando le fotografie scattate – molte anche prima del 2014 – mi sono reso conto che tutte queste potevano appartenere a un’unica, grande nazione. Alcune, in particolare, non ricordandomi dove le avevo realizzate, non riuscivo a collocarle nemmeno cercando immagini simili all’interno del mio archivio. Ecco come, da Ostalgie, ha preso poi vita il progetto Arca Russa.
Tenuto conto della crisi dell’editoria, la fotografia di reportage ha sempre più senso di esistere nel momento in cui si affronta un percorso di approfondimento, magari lontano dalle redazioni, o si può ancora pensare di vivere di commissionati?
Avendo sempre fatto reportage, ritengo che si debba scegliere fra due strade. Si può seguire la cronaca, realizzando immagini giornalmente, magari anche a discapito della qualità – molti devono inviare le immagini senza avere il tempo di fare una selezione – e con uno stipendio fisso o impegnarsi in servizi che per forza di cose hanno bisogno di tempo. I lavori che considero belli e buoni richiedono almeno un minimo di indagine sul campo. Alcuni commissionati possono funzionare, ma perché ciò avvenga è necessario trovare il giornale che abbia voglia di investire – e sono sempre meno. Nel 2016, per esempio, ho ricevuto un incarico dal New York Times sulla crisi bancaria in Italia. È durato quattro giorni. Questi lavori possono capitare due tre volte l’anno; non è così facile.
Pensando ad alcune grandi firme della fotografia, quali ti vengono in mente?
Sono di ispirazione Elliott Erwitt e Martin Parr per la loro ironia e anche Alec Soth perché ha cambiato il linguaggio nel fotoreportage. Il suo libro Niagara è e dovrebbe essere la bibbia oggi per un fotografo che vuol fare reportage.
Sei un fotografo e sei anche un giornalista. Anzi, prima di prendere in mano la macchina fotografica collaboravi con l’Ansa e con altre agenzie. Riconoscono in te un certo fiuto per le storie.
Ti racconto un aneddoto. Alcuni anni fa iniziarono le prime scaramucce tra Russia e Ucraina e uscì la notizia che Kiev avrebbe cancellato il russo come lingua ufficiale. Pensai, quindi, che era venuta l’ora di acquistare un biglietto per la Crimea. Sentivo che la guerra era alle porte. Non riuscii ad andare perché effettivamente la guerra scoppiò subito dopo e furono cancellati tutti i voli. A quel punto scattò il fattore pigrizia e restai a casa. Me ne pentii mesi dopo. Pur essendo giornalista professionista, ho scelto di non scrivere più. Penso che il fotogiornalismo sia un linguaggio già in se stesso. Un racconto per immagini non è solamente, come spesso si crede, delle immagini che si affiancano al testo scritto. In Italia è un concetto complicato da far comprendere.
[envira-gallery id=”19022″]
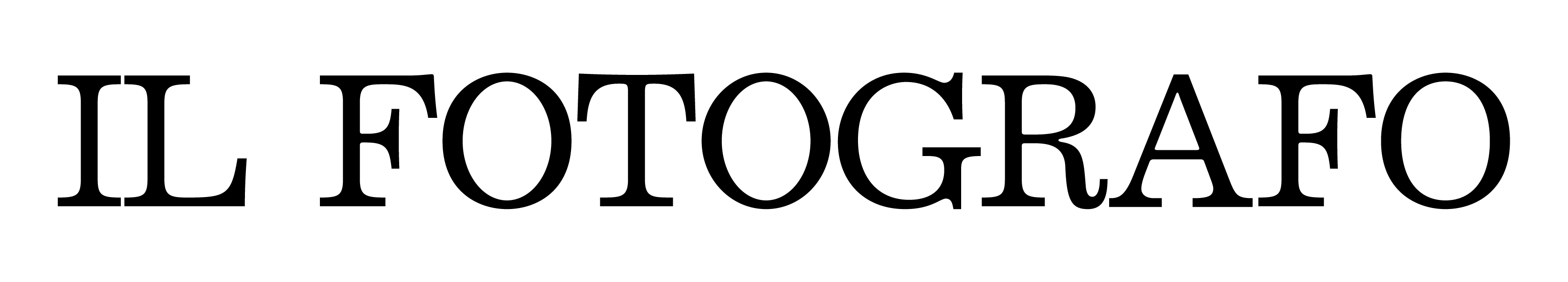
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





