Prosegue il nostro racconto dedicato alla magia, e alle tante insidie, della stampa in camera oscura. Un’operazione che vedeva i fotografi dell’era pre-digitale trasformarsi in piccoli chimici…
Camera oscura: questione di chimica
Domata la pellicola, infilata la spirale nella tank e chiuso il coperchio, si poteva accendere la luce. Era il momento solenne delle grandi decisioni: quale chimico di sviluppo? Con quale diluizione? Per quanto tempo? A quale temperatura? E con quale agitazione (l’operazione di invertire la tank più o meno energicamente e a intervalli variabili)?
Mentre alcuni si affidavano all’istinto, altri studiavano meticolosamente il “bugiardino” dei chimici e altri ancora consultavano i propri taccuini fitti di numeri misteriosi e simboli strani. Poi, badando a non macchiarsi gli abiti con gli acidi – un fatto abbastanza frequente – il piccolo chimico che era in noi dava inizio alle sue alchimie, mescolando e diluendo prodotti dai nomi impronunciabili, misurandone la temperatura con appositi termometri, maneggiando e facendo volteggiare la tank con l’occhio attento al timer che scandiva i secondi e segnalava i minuti. Alcuni prodotti erano in polvere: dovevano essere preparati in anticipo e poi lasciati raffreddare.

Questa prima importante fase della liturgia durava dai cinque ai quindici minuti circa. Poi veniva il momento di introdurre altri chimici destinati a interrompere l’effetto dei primi e a fissarlo inesorabilmente.
Ciò fatto, bisognava collegare la tank al rubinetto dell’acqua. La cosa avveniva mediante una cannetta di gomma munita di appositi adattatori, che ricordava spiacevolmente un clistere. Lavaggio in acqua corrente per venti minuti o mezz’ora e finalmente, con una certa dose di apprensione, apertura della tank, estrazione della pellicola (bagnata e quindi vulnerabile) ed esame del risultato: densità, contrasto, macchie eventuali, presenza di pelucchi e rigature da calcare, nonostante il rubinetto fosse provvisto dell’apposito filtro.
Per asciugare le pellicole, non restava che appenderle come la biancheria, esponendole però al pulviscolo atmosferico che invariabilmente aderiva conglomerandosi all’emulsione umida e da lì non lo cavavi più. Senza considerare le sempre possibili striature causate dal malefico calcare. Pochi, a parte i laboratori, disponevano degli armadi essiccatori.
Operazioni preliminari
La stampa si addiceva agli insonni perché i tempi erano biblici e l’operazione avveniva nottetempo. Di notte, infatti, era più facile oscurare il bagno o la cucina. Una camera oscura vera e propria era privilegio di pochi, perché doveva essere un locale relativamente grande, climatizzato, a totale tenuta di luce e dotato di acqua corrente a temperatura controllata.
L’illuminazione durante la stampa era fornita da speciali lampade giallo-verdi o rosse, secondo il tipo di carta impiegato, che definire fioche è eufemistico.
Prima di dare inizio alla stampa, si facevano i cosiddetti provini a contatto con un “torchietto provinatore” Paterson. Era un vetro con sei guide nelle quali era infilata la pellicola tagliata in strisce da sei fotogrammi, incernierato su un piano a sua volta rivestito da un sottile strato di spugna sintetica. In camera oscura, si appoggiava un foglio di carta sensibile 24×30 sul piano con la spugnetta.
Quindi, si chiudeva il vetro che un apposito gancetto teneva pressato contro il foglio e la spugna, e si esponeva l’oggetto alla luce dell’ingranditore per alcuni secondi. Il foglio esposto era poi sviluppato normalmente nelle tre bacinelle di sviluppo-arresto-fissaggio, lavato, asciugato nella smaltatrice e “pinzato” alla custodia di carta velina che conteneva i corrispondenti negativi.
Quali foto stampare?
La scelta delle foto da stampare avveniva esaminando con una lente d’ingrandimento, detta “lentino”, il foglio dei provini a contatto. I provini davano anche una prima indicazione sul tipo di carta da usare. Infatti, fino alla metà degli anni ’80, le carte esistevano in cinque o sei gradazioni che ne determinavano il contrasto. Un fotografo doveva, quindi, interpolare i dati relativi alla finitura (matt, semi-matt, lucida) alla marca (con tutti i tipi di grammatura, resa del nero e aspetto che ogni produttore aveva in catalogo) e alla gradazione.
Superata la delusione per i numerosi errori di esposizione e inquadratura riscontrabili già a un primo esame dei provini, si infilava il negativo prescelto nel vassoio dell’ingranditore. Quindi si alzava o abbassava la testa dello strumento in modo che proiettasse l’immagine nella dimensione e con il taglio desiderato. Si metteva a fuoco l’ottica dell’ingranditore e si esponeva una striscia di carta sensibile.
Ovviamente questo cerimoniale era “illuminato” (è solo tanto per dire) dalla fioca lampadina giallo-verde o, peggio, rossa.
Finalmente… si stampa
Stabilita l’esposizione, aveva inizio la stampa vera e propria. Soprattutto se il foglio era di grandi dimensioni (30×40 centimetri e oltre), il prelievo dalla scatola era un gesto mistico e sacrale, dato il valore intrinseco del materiale sensibile. Con adeguata solennità questo veniva sistemato sul marginatore, un piano di metallo con quattro specie di righelli che, sovrapponendosi al foglio di carta sensibile, lo proteggevano dalla luce creando i margini, stabilivano il taglio e lo tenevano piatto.
Lasciato a se stesso, il foglio avrebbe infatti assunto una forma concava o convessa secondo il capriccio degli spiriti che aleggiavano nell’ambiente e questo avrebbe vanificato la messa a fuoco fatta poc’anzi con non poco sforzo.
Raramente l’esposizione era uniforme su tutto il foglio. Sovente era necessario “proteggere” dalla luce alcune parti che sarebbero diventate troppo scure e per questo si usavano le mani che, come le ombre cinesi, coprivano le parti a rischio.
Per contro, altre parti avevano bisogno di più luce ed era quindi necessario convogliarcela con un supplemento di esposizione durante la quale tutto il foglio era protetto (con le mani) tranne la parte da correggere. Alcuni usavano bastoncelli e cartoncini ritagliati in varie, bizzarre fogge.
Con gesto deciso, il foglio esposto era quindi infilato a faccia in giù sotto la superficie del primo bagno, agitato dolcemente e girato più volte. Quindi, nella semi-oscurità giallastra o rossastra si assisteva al miracolosa epifania dell’immagine. Il momento era carico di emozione. Ma prima di accendere la luce e poter contemplare l’opera, era necessario che il foglio fosse immerso in altri due bagni: l’arresto e il fissaggio. Ma era questione di pochi minuti.
Il momento fatidico in camera oscura
L’accensione della luce portava sempre con sé un po’ di trepidazione. Preludeva, infatti, al primo vero giudizio sulla fotografia. A volte permetteva anche di constatare come, nella concitazione del momento, ci si fosse dimenticati di chiudere il pacco di carta vergine, a beneficio del sacco dell’immondizia.
Raramente il risultato era subito soddisfacente. Una buona stampa, infatti, si otteneva dopo tentativi che si prolungavano per ore. Nel frattempo un nemico invisibile tramava costantemente contro di noi: la polvere.
Per quanto pulissimo il negativo con un panno speciale per eliminare le cariche elettrostatiche, i puntini bianchi di polvere apparivano invariabilmente sulla stampa. E più la guardavi più ne vedevi. Per non parlare del flagello dei graffi sulla pellicola prodottisi durante lo sviluppo. O degli aloni dati dalle tracce di calcare, sopravvissuti all’asciugatura nonostante l’uso degli appositi filtri per l’acqua di lavaggio.
L’unico rimedio a tutto questo consisteva in una minuziosa e paziente operazione di spuntinatura che poteva avere inizio dopo l’asciugatura della stampa mediante la smaltatrice. Spuntinare una stampa era un’operazione da amanuense, perché non solo bisognava intervenire con il pennellino solo sulla parte ammorbata.
La vera difficoltà era diluire il nero al punto giusto per imitare la gradazione di grigio sulla quale intervenire e un pilucco su una sfumatura poteva attraversare infinite gradazioni di grigio. Per non parlare dei diversi tipi di carta con diversi tipi di nero, più caldo o più freddo.
Provare per credere
Coloro che volessero provare tutte queste intense emozioni, trovano oggi in libera vendita tutto quello che è stato citato in queste pagine – segno inconfutabile del rinnovato interesse per questo modo di fotografare. Possono, dunque, facilmente allestire la loro camera oscura. Grandi amarezze, ma ancor più grandi soddisfazioni, non mancheranno.
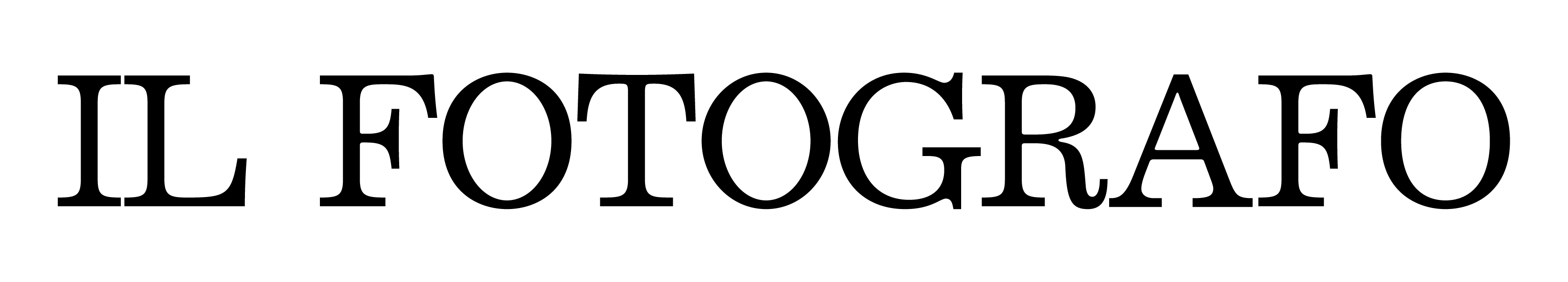
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI






Quanto è vero, ancora sviluppo e stampo da me in una minuscola camera oscura, e le emozioni sono sempre le stesse. Complimenti per il racconto molto bello