
1979, Kabul, Afghanistan Pochi giorni dall’invasione sovietica, davanti al carcere di Pule Charkhi, i parenti dei detenuti politici sono in attesa della loro scarcerazione
Com’è il mestiere del fotoreporter? Complicato. In Italia è una professione che se non è già morta, sta morendo. Bisogna essere prima di tutto un giornalista, poi un fotografo. È necessario saper raccontare una storia visiva, dando nello stesso tempo tutte le informazioni utili. C’è un parallelo tra il giornalismo per immagini e il giornalismo scritto, nel senso che un racconto si può scrivere in modi differenti. L’importante è essere sempre chiari e, prim’ancora, ben informati su cosa si va a fotografare. Su tutto. Fondamentale è conoscere la storia di quel luogo e degli eventi. Le immagini devono avere un contenuto di valore informativo altrimenti non valgono nulla. È la ragione per la quale in Italia i direttori dei giornali non comprano più fotografie. E fanno benissimo. Si affidano, abbonandosi a un servizio, a importanti agenzie straniere che sono cresciute nel tempo e che hanno al loro interno reporter validissimi. In Italia, le agenzie, anche le più importanti, non parlano di fotogiornalismo, ma di progetti, di percorsi – un cumulo di cose perlopiù campate per aria –. L’avvento del digitale, inoltre, ha avuto un peso determinante nell’ammazzare definitivamente questa professione.

1987, Peñas Blancas Costa Rica. Marito e moglie si abbracciano attraverso “la rete della vergogna”
che separa Costarica e Nicaragua. A nove anni dalla rivoluzione sandinista, i nicaraguensi calano verso sud cercando di passare
il confine. Ogni giorno, in centinaia si ammassano lungo la rete per raccogliere il cibo portato dai parenti più fortunati, quelli che sono riusciti a oltrepassare la frontiera
Cosa suggerirebbe a un giovane che desidera avvicinarsi a questa professione? Avendo fatto circa sette-otto volte il giro del mondo si imparano un bel po’ di cose e ci si accorge da vecchi di non averne imparate abbastanza. Si parla di voto ai sedicenni, invece sarei dell’idea di toglierlo ai diciottenni. C’è poca cultura. Alcuni giovani studiano benissimo la loro materia, ma poi sanno pochissimo del resto. In Italia ci sono sempre le stesse persone che si occupano di fotografia. Purtroppo hanno in mano tutta la cultura della fotografia e continuano a dire sempre le stesse cose. I giovani che intendono intraprendere questa professione non possono rimanere in Italia altrimenti devono compiacere i soliti noti. Credo che l’unica strada oggi sia di andarsene negli Stati Uniti. È un altro mondo, professionalmente parlando. Ci vorrebbe una bella rivoluzione culturale. Ricominciare da capo. Inoltre, ai giovani bisognerebbe dare anche la prospettiva di lavorare nel fotogiornalismo in maniera seria. Fra loro ci sono grandi potenzialità. La storia è fondamentale. Oggi, abbracciare subito la professione diventa autoreferenziale. Devono scoprirsi, scoprendo il mondo.
di Raffaella Ferrari
Mauro Galligani

Frequenta il corso di direttore della fotografia presso la Scuola di Cinematografia di Roma. La storia del cinema e i maestri del Neorealismo formano la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il Giorno ed è a contatto con la migliore scuola di giornalismo italiano che, da allora, segna la coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture editor. Per questa testata segue i grandi avvenimenti della cronaca internazionale. Alla chiusura di Epoca passa a Panorama come picture editor. Per molti anni ha collaborato con Life.
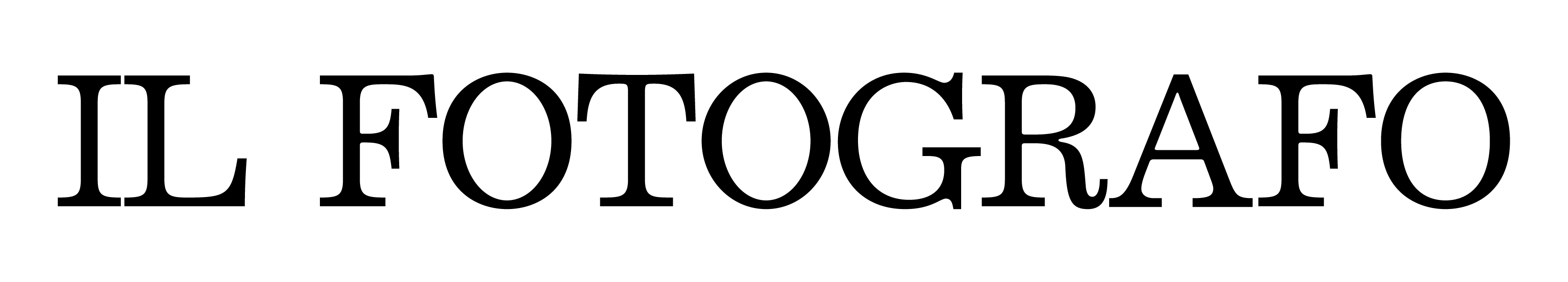
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





