Jonathan, eri preparato a tutto questo? La Bolivia è un’esperienza estrema (come mi disse un alpinista che vive in Cile e che ha scalato anche gli 8mila metri). Per quanto tu possa essere preparato, riesce sempre a superare le aspettative. E poi, al di là delle difficoltà fisiche, che comunque possono essere affrontate, questo viaggio è molto impegnativo anche sotto il profilo umano. Mi è capitato di leggere, sul muro di un edificio sperduto in mezzo alle Ande, una scritta in spagnolo: “Miles han vivido sin amor, y ni uno solo sin agua” (Mille vissero senza amore, nessuno senza acqua). Come dire, qui la sopravvivenza è così difficile che prende il sopravvento sopra ogni altra cosa.
A proposito di condizioni estreme, ci racconti la tua esperienza nelle miniere boliviane?
Le guide avvisano dei seri rischi che la loro visita può comportare, perché le miniere sono funzionanti. Prima di entrare, ti vestono come se fossi un minatore, con tuta, stivali, torcia sulla testa. Inoltre, si trovano a circa 4.500 metri di quota e la fatica è tanta. Si entra in questo cunicolo buio, non c’è illuminazione, l’unica luce è quella delle torce. I minatori fanno una vita infernale, muoiono giovanissimi di silicosi, la loro gioventù è bruciata da un lavoro durissimo nella speranza (difficilissima) di diventare ricchi. Il tasso di mortalità tra loro è estremamente elevato.

Nelle miniere, ho usato un’apertura f/1.4: la profondità di campo è cortissima ma mi interessava catturare l’espressione dei giovani minatori.
Anche per quanto riguarda la fotografia è molto complicato, perché non c’è luce e in più devi stare attento a non farti travolgere dai carrelli che trasportano fuori il materiale estratto dai minatori. Ti trovi a fotografare nella totale imprevedibilità, le persone si muovono, il buio è totale. Ho utilizzato un’ottica estremamente luminosa, un 35 mm fisso f/1.4, perché volevo la massima nitidezza e non volevo usare il flash. Volevo catturare la vera luce, le vere condizioni di lavoro. Avevo già settato la macchina, perché in queste condizioni non hai tempo di impostarla dopo, devi cercare di prevedere quello che accadrà. E poi, vada come vada.
Sotto il profilo naturalistico, quali luoghi meritano di essere scoperti per immagini diverse dal solito? Il percorso che io ho seguito non è tra i più battuti, ma anche in questo itinerario c’è la possibilità di aggiungere delle “perle rare” che praticamente nessuno va a vedere. La prima è la Ciudad de Roma, chiamata così perché le sue formazioni rocciose ricordano la monumentalità della città eterna. Poi, accanto al Salar de Uyuni, la più grande estensione di deserto di sale al mondo, c’è il Salar de Coipasa, spesso trascurato perché più piccolo. È stato fantastico, perché ho potuto ammirare il salar allagato anche durante la stagione secca. Anche sotto l’aspetto fotografico è stato complicato: l’acqua sotto di te riflette il cielo ed entri in confusione, perdi le coordinate. Tutto si confonde e gestire la macchina fotografica è arduo, soprattutto per la messa a fuoco. È un’esperienza surreale, ma indimenticabile.

I raggi del sole illuminano i cactus dell’Isla Incahuasi. Tutto intorno, il bianco del Salar de Uyuni.
Altri luoghi suggestivi sono stati due geyser, quello del Tatio a 4.300 metri in Cile e quello del Sol de Mañana a 5.000 metri in Bolivia. In quello cileno sono arrivato all’alba e mi sono trovato in un campo pieno di soffioni di vapore acqueo sgorgante dalla terra. Ho fotografato a -20 gradi, non sentivo più le mani, ma non volevo smettere di scattare. A un certo punto, i raggi di sole hanno cominciato ad attraversare le colonne di fumo e ho scattato un’immagine in controluce: sotto i colori della terra, la madre terra, sopra il vapore trafitto dai raggi di sole. È un momento che porterò sempre con me.

Il passaggio lunare dei geyser del Tatio in Cile, avvolto dal vapore acqueo.
Indimenticabile è stata anche la discesa in bicicletta lungo la Carretera de la Muerte, così chiamata perché mediamente avveniva quasi un incidente mortale al giorno. È una strada molto particolare, strettissima, in larga parte sterrata, senza alcuna protezione dal lato del precipizio; parte da circa 4.700 metri di quota e scende fino a 1.200 metri. Nel mondo non c’è una strada simile, è straordinaria perché attraversi tutte le possibili gradazioni di vegetazione, dai ghiacciai perenni alle palme tropicali.
Jonathan Brioschi

Nato a Milano, vive e lavora a Roma. Viaggiatore appassionato e apprezzato fotografo, negli anni ha organizzato numerosi viaggi accompagnando centinaia di persone nei cinque continenti. Ha esplorato i luoghi più remoti della Terra: dal deserto del Sahara e del Gobi alla Dancalia, all’Isola di Pasqua.
I suoi reportage sono stati presentati in mostre e in televisione, oltre che pubblicati su prestigiose riviste. Esperto di cultura di viaggio, è stato ospite in serate fotografiche e in radio. Tiene un corso di fotografia improntato alla street photography e alla fotografia di viaggio.
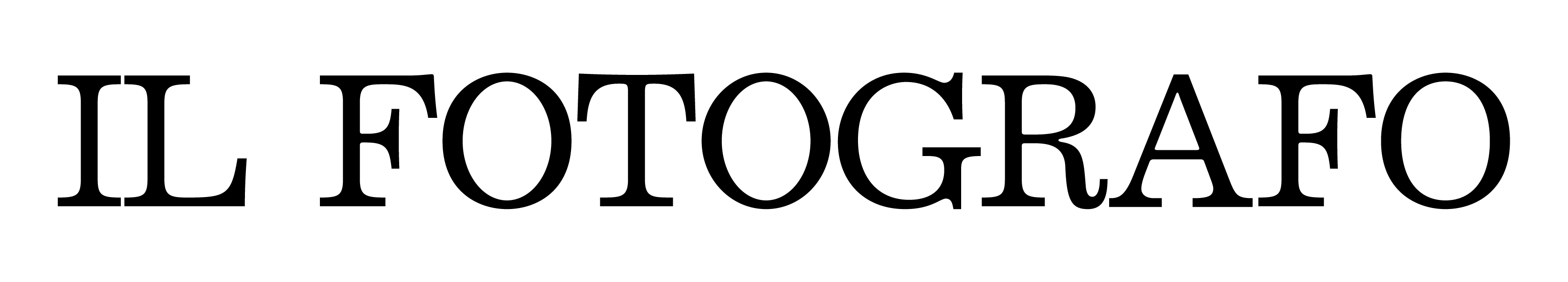
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





