Alessandro Lorenzelli, fotografo professionista del collettivo Divergence, ci racconta del suo viaggio in Cambogia e della toccante visita nelle carceri del regime dittatoriale di Pol Pot e dei Khmer Rossi. Una storia fatta di tragici ricordi ancora vivi e limpidi nella mente del popolo cambogiano.
Sembra tutto così normale. Dall’esterno e da leggermente lontano. Un ingresso tra il bianco e l’azzurro, l’edificio rovinato dal tempo e dal sole come una gran parte della Phnom Penh che lo circonda. Alberi che sbucano dai muri di confine, fiori. Poi, un po’ più vicino, il filo spinato. Quello più nuovo, con le lame piccole al posto delle punte di ferro ritorte.

© Alessandro Lorenzelli, Phnom Penh, 2016
Un tempo era una scuola superiore, la Tuol Svay Prey High School, il regime dei Khmer Rossi l’aveva requisita, trasformata e chiamata Ufficio di Sicurezza 21, S21, la Sala della Santebal, la polizia segreta del regime. Oggi ospita il Tuol Slang Genocide Museum. Tuoi Slang, “la collina degli alberi velenosi”.
Si arriva ad un ingresso ben organizzato, tornelli e biglietteria, volantini informativi in più lingue, personale cordiale, sorridente. Se guardi bene, però, stranamente rispetto al resto dei sorrisi cambogiani, questi si spengono quando raggiungono gli occhi. Ho letto molto prima di arrivare qui, volevo vedere, volevo provare a capire perché, ovunque nel mondo, alcuni uomini si accaniscono con violenza e crudeltà contro altri uomini. Volevo provare ad intuire. Lo stomaco inizia a stringersi, l’istinto inizia a lavorare e percepire. E non vedi più le foglie verdi, non senti più il canto degli uccelli, onnipresenti, non odori più i profumi. Tutto il tuo essere entra in modalità sopravvivenza, solo la base, solo primario. Tranne un groppo in gola.

© Alessandro Lorenzelli, Phnom Penh, 2016
S21 inizia la sua storia nel 1975, si chiude nel 1979. Inizia con essere il campo di fucilazione dei nemici del popolo, i borghesi, i collaborazionisti, finisce per diventare uno dei centri principali per l’epurazione dei “deviazionisti”, tutti quelli fuori dai confini dell’ortodossia di Pol Pot. Chiunque. Dipende. Ci dicono che ci sono passati in 17.000 – si presume, ma forse sono di più – ne escono vivi in 7. Uno sta seduto sotto un albero del cortile, se vuoi puoi parlarci, sentire dalla sua voce. Magari alla fine del giro.

© Alessandro Lorenzelli, Phnom Penh, 2016
Il giardino ancora ricorda la tranquillità di una scuola, da lontano sembra che ci sia pure un’altalena. Più vicine invece, vicino all’ingresso, le tombe delle ultime vittime trovate nella S21, dopo la fuga dei Khmer nel 1979. L’hanno scoperta per il fetore.
Ci sono numeri da seguire, un percorso come tu fossi un prigioniero. C’è l’audioguida, non credo serva. Puoi leggere di S21 ovunque. Qui devi ascoltare altro. Devi ascoltare loro, se riesci a sentirli. Si salgono le scale.
Ancora si vede luce, si vede il sole, a sinistra del lungo corridoio le porte, il ballatoio a destra si affaccia sul giardino, si vedono gli altri edifici, cinque in tutto. Non si ha immediatamente voglia di guardare a sinistra. Ma ti volti.

© Alessandro Lorenzelli, Phnom Penh, 2016
C’è una stanza vuota, i muri scortecciati, rigati, macchiati, qualche scritta in cambogiano fa da cornice bassa alle pareti. Macchie sul pavimento. Nel mezzo dei letti, meglio delle reti in ferro approssimative, un pagliericcio distrutto si spera dal tempo. Sbarre alle finestre, travi e tavole bloccano la vista sull’esterno, una serie di fori in alto fa un minimo di luce. Ci saranno quaranta gradi, per quanto si suda. Non hai più uno stomaco, ma una pallina stretta. Il cervello inizia ad andare in risonanza.
Una dietro l’altra, almeno una decina di stanze, identiche, stessa condizione, ti conducono scortandoti alla fine del ballatoio. Ci sono scale da scendere, il buio è sovrano e lascia appena intravedere qualche colore, un po’ di blu e verde. Ma non ci fai caso.

© Alessandro Lorenzelli, Phnom Penh, 2016
Alla fine delle scale esci di nuovo in cortile. L’altalena non è un’altalena, ma una struttura, una forca con delle giare in terracotta. Ci attaccavano i prigionieri per i piedi, la testa dentro la giara piena d’acqua, immagino, no, lo leggo, piena d’acqua. In S21 non c’erano esecuzioni sommarie, se uccidevi così un prigioniero rischiavi di finire tra i prigionieri. Ma si moriva di soprusi. Si cercano confessioni, si impongono le regole della prigione:
1. Devi rispondere attenendoti alla mia domanda. Non tergiversare.
2. Non cercare di occultare i fatti adducendo pretesti vari, ti è severamente vietato contestarmi.
3. Non fare il finto tonto, perché sei un controrivoluzionario.
4. Devi rispondere immediatamente alle mie domande senza sprecare tempo a riflettere.
5. Non parlarmi delle tue piccole azioni immorali o dell’essenza della rivoluzione.
6. Non devi assolutamente piangere mentre ricevi l’elettroshock o le frustate.
7. Non fare nulla, siediti e attendi i miei ordini. Se non ci sono ordini, rimani in silenzio. Quando ti chiedo di fare qualcosa, devi eseguire immediatamente senza protestare.
8. Non inventare scuse sulla Kampuchea Krom (N.d.A. la nazione khmer) per nascondere i tuoi segreti da traditore.
9. Se non segui tutte le regole succitate, riceverai moltissime frustate con il cavo elettrico.
10. Se disubbidirai ad una sola delle mie regole riceverai dieci frustate o cinque scosse elettriche.

© Alessandro Lorenzelli, Phnom Penh, 2016
Si entra in un altro edificio. Le celle non sono più come quelle del piano di sopra, qui c’erano aule più grandi. Sono state divise sommariamente, da muri di mattoni e sbarre di ferro, in celle minuscole. Qui si stava incatenati ai muri. In quelle grandi i prigionieri erano legati tra loro con una sbarra di ferro.
Ci sono tante foto. Ci sono tanti volti che ti guardano. Alcuni sono consapevoli che dove un tempo si creava il futuro dei giovani, adesso si cancellava il futuro di chiunque. Qualcuno ancora riesce a sorridere, la macchina fotografica è più forte della paura e dell’aguzzino là dietro, d’istinto gli occhi s’illuminano e parte il sorriso. Direi l’ultimo. Ci sono donne, bambini, vecchi che si sono arresi, giovani che ancora hanno fierezza negli occhi neri. Ci sono soldati, ci sono occidentali, un paio di australiani, qualche francese, un americano morto tra gli ultimi. Se ne vedono di volti. Qui le differenze non ci sono. La livella.

© Alessandro Lorenzelli, Phnom Penh, 2016
Ci sono ancora macchie di sangue sul pavimento. Una lavagna verde crepata registrava i nomi di quelli nelle celle. Il sole passa tra le celle e le sbarre. Acceca. Attraversa un buco fatto nel muro per permettere ai “responsabili” della prigione di passare velocemente da stanza a stanza, senza perdere tempo a fare il giro. Tutto ottimizzato. Tutto disegnato per la distruzione sistematica dell’essere umano, no, anzi, del nemico del popolo. Gli esseri umani non erano presi in considerazione.

© Alessandro Lorenzelli, Phnom Penh, 2016
Immagini sevizie e torture, i dettagli che vedi raccontano di una maniacale perfezione, una registrazione di tutto, l’attenzione al piccolissimo, il fatto che eri proprio tu, tutto quello che tu rappresentavi, al centro di quest’attenzione folle. Tu, proprio tu. Uno per uno, uno per diciassettemila. Solo qua dentro.
Uscivi dalle stanze di S21 solo per vedere il sole rigato di filo spinato, quello con le lame, il retro di un camion. Choeung Ek, i killing fields. Tutto finito.
Con l’uomo sotto l’albero non ci ho parlato. Non avevo né coraggio né parole.
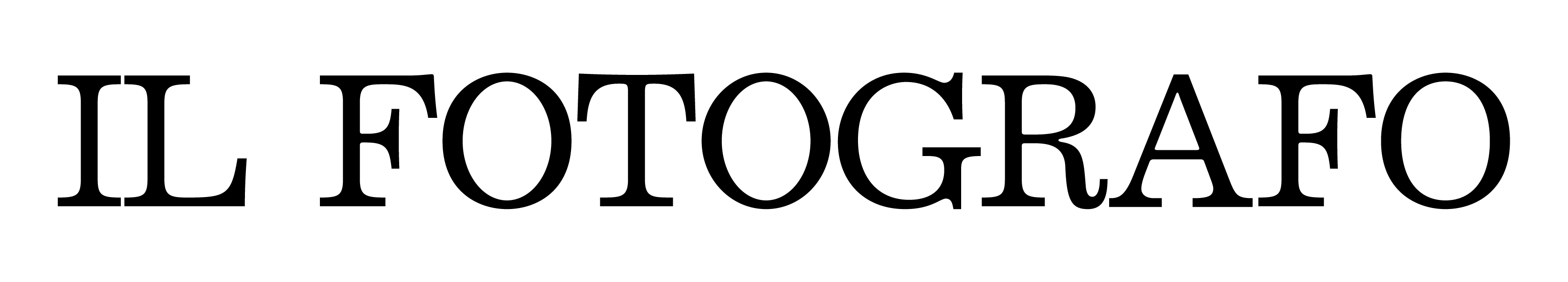
 Abbonati
Abbonati I nostri manuali
I nostri manuali LOGIN/REGISTRATI
LOGIN/REGISTRATI





